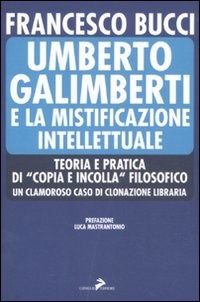
Qualcuno (forse) ricorderà il clamore che nel 2011 suscitò il volume di Francesco Bucci Umberto Galimberti e la mistificazione intellettuale, dedicato al curioso vizio del filosofo monzese di plagiare non solo gli scritti altrui, ma addirittura i propri. L’affaire per qualche tempo fu sollevato da Il Giornale, fino al prevedibile silenziamento (per i casi della vita, l’editore che aveva pubblicato il libro chiuse i battenti qualche mese dopo) e al rilancio immediato della figura di Galimberti come ospite d’onore di terze pagine, festival e talk show.
Non era difficile prevedere che la vicenda non avrebbe influito in alcun modo sulla fortuna accademica e mediatica del personaggio. Se tuttavia Bucci ha preferito gettare la spugna (non per codardia: nel 2013 ha pubblicato un volume contro Eugenio Scalfari), al contrario chi continua a denunciare le scorrettezze di Galimberti è Vincenzo Altieri (il primo a lanciare il “caso” segnalando nel 2008 sempre a Il Giornale diversi déjà-vu emersi dalla lettura di una sua opera), che dal suo sito denuncia (anzi denunciava, perché nel frattempo è scomparso pure quello) sistematicamente ogni nuovo plagio (la lista si è allunga con gli anni di nomi noti: Bataille, Barthes, Baudrillard, Bauman, Foucault, J. Hillman, Levinas, Marcuse…).
Di recente Luigi Mascheroni, riprendendo una lapidaria definizione di Matteo Sacchi, ha descritto Galimberti come “l’unica macchina fotocopiatrice che abbia mai ottenuto una cattedra universitaria” (nel volume Elogio del plagio appena edito da Aragno): più che di una semplice cattedra, in realtà parliamo di un vero e proprio magistero all’apparenza inscalfibile.
Il motivo per cui tutto ciò accade è stato indirettamente confermato da un’apologia del filosofo pubblicata ai tempi da MicroMega (In difesa di Umberto Galimberti, 22 aprile 2011): in sintesi potremmo dire che, almeno in ambito culturale e umanistico, nel Bel Paese vige ancora l’argumentum ab auctoritate (e l’autorità a cui si riferisce è quella generalmente riconducibile a “sinistra”).
A causa di una implicita divisione di “ruoli” che nel dopoguerra i partiti si imposero per mantenere ordinata la novella repubblica, l’ambito del culturale finì ad appannaggio delle forze genericamente progressiste (seppur progredenti nelle tenebre), il politico alla “destra” e l’economico all’area grigia liberale e azionista. Ancora oggi gli assetti di poteri rispecchiano questo ukase, come dimostra (per fare l’esempio più facile) la composizione standard del “cast” di un qualsiasi dibattito televisivo: intellettuali di sinistra, politici di destra ed economisti liberisti.
In questo schema si inserisce il terrificante panegirico di MicroMega (tralasciamo che, dopo aver biasimato la “metamorfosi culturale verso il basso”, l’autore non trovi di meglio che paragonare il proprio paladino a Maradona e Madre Teresa di Calcutta; sorvoliamo ugualmente sull’imbarazzante ripiego con cui i plagi vengono trasformati in “esigenze della divulgazione”): il punto è che la rivista di Flores d’Arcais giustamente identifica “il problema cruciale della cultura italiana”
«nella pretesa di individuare nelle importanti figure che rappresentano la vera cultura della Penisola quei – veri o falsi che siano – piccoli limiti che la possono caratterizzare in totale dispregio dei fondamentali contributi che il loro pensiero, e le loro opere, hanno dato al Paese».
Argumentum ab auctoritate, come detto. Tuttavia non dovrebbe stupire che una “cultura” tenuta all’ombra, rinchiusa nelle riserve, ghettizzata fino all’estremo dia il meglio di sé nell’acribia e nella causticità critica; semmai ciò appare come il risultato di una dinamica piuttosto elementare: quando un gruppo sociale (o solamente “culturale”) viene condannato all’invidia, è naturale che esso arrivi a farne un arte, uno stile, a proiettare il suo atteggiamento più in alto possibile, oltre ogni autorità e scuola.
La fortuna della destra italiana è di essere da sempre una delle più corrosive, fieramente orientata alla disintegrazione sistematica di ogni sistema: è per questo che il volume di Bucci, per nulla politicizzato, è ridotto suo malgrado a manufatto di un’inesistente “egemonia berlusconiana” (chissà se da quelle parti la chiamano ancora così?) e, in senso positivo, sarebbe suscettibile di trasformarsi nell’espressione di quello spirito iconoclasta che la destra è riuscita a mantenere vivo (anche se più per “cattività” che per volontà esplicita). Del resto il compito di abbattere gli idoli, nonostante la penuria di mezzi, rimane ancora uno dei più nobili…







Buongiorno,
premettendo la mia genetica propensione all’anarchismo dunque scevro da derive d’ogni punto cardinale, perchè il Sig. Bucci, invece di impegnare il proprio tempo per scandagliare e evidenziare tutte le scopiazzature del Galimberti, non scrive anche lui qualche libello interessante su ciò che più gli aggrada? Non ho letto, e non intendo farlo, il libro del Bucci, ma sono certo che esso contenga tutte cose vere e certificate, ma la questione finale è: se Galimberti con un ardito patchwork confeziona un libro interessante, godibile e, sopratutto leggibile, perchè strapparsi le vesti urlando al plagio? Cordiali saluti
Non è “ardito patchwork”, è puro plagio, interi passaggi copia-incollati… non mi sembra il caso di giustificare questo comportamento, soprattutto da parte di un “venerato maestro”