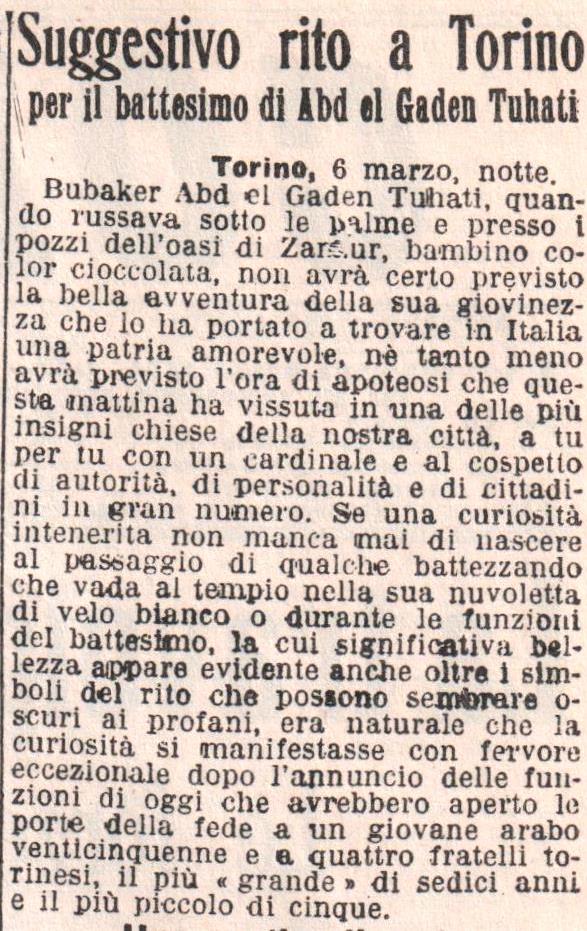Nel 2000, una certa Angela Dorothea Kasner, fresca Presidentessa della CDU, invocava dai banchi dell’opposizione un inasprimento delle leggi contro l’immigrazione in Germania. Dieci anni dopo, l’astro nascente del conservatorismo tedesco, ormai divenuta per tutti ufficialmente Angela Merkel, entrò nuovamente nella storia della xenofobia europea con il celebre discorso del Multikulti ist gescheitert, ripreso in modo acritico da tutta la stampa mainstream d’allora («Gli immigrati si devono integrare e devono adottare la cultura e i valori tedeschi»): in un’Unione Europea in cui le élite politiche locali si rifanno a Berlino, tali affermazioni generarono un effetto valanga e le sortite di Angela vennero immediatamente replicate da David Cameron (State multiculturalism has failed, 5 febbraio 2011) e Nicolas Sarkozy (Le multiculturalisme est un échec, 10 febbraio 2011).
Sembrava finalmente giunto il momento di una riflessione realistica e non ideologica o politicamente corretta sul fenomeno; col senno di poi, è stato invece l’inizio della fine: nel 2015 la Merkel perdeva ogni freno inibitorio e con la sua politica di “porte aperte a tutti” si inimicava mezzo continente (soprattutto gli “Stati satelliti” dell’Europa Orientale). Comprendere cosa sia successo non è per nulla semplice, tanto più che il problema ormai deve passare dalle mani dei giornalisti (che in realtà si sono sempre rifiutati di “afferrarlo”) a quelle degli storici.
La Merkel scherzava? Parlava a vanvera? Oppure era tutto un piano diabolico a priori, che però si può leggere in entrambi i sensi, cioè o per dirottare l’elettorato conservatore verso l’immigrazionismo spinto, oppure per far collassare i sistemi d’accoglienza europei dimostrando così a contrario il fallimento del multiculturalismo?
A parte gli scherzi, l’ipotesi più inquietante resta quella di una “persuasione” talmente potente da convincere il più importante leader europeo a suicidarsi politicamente in pubblico. Dare sempre la colpa a Soros, per quanto appagante, è un modo come un altro per cercare un capro espiatorio. Osservando però la situazione da una distanza di sicurezza, vediamo come il problema principale della Germania odierna sembra sia rappresentato dal perverso intrico di politica, industria e finanza che informa il “modello tedesco”.
Tale garbuglio fa assomigliare la nazione a una gigantesca macchina divoratrice di popoli: potremmo definirla, sulla scorta di Omero (o Rabelais), una nazione demovora. Anche chi la governa si presterebbe bene alla definizione di mangeuse de peuples, ma sarebbe scorretto praticare nel nostro piccolo la schwarze Magie delle gazzette, che dividono gli animi e li conquistano attribuendo le responsabilità della situazione attuale a una Mutti materna o dominatrice a seconda delle circostanze (come abbiamo appena visto).
Finanza, industria e politica, si diceva. Per dividere sommariamente i campi, potremmo iniziare affermando che le esigenze della finanza sono quelle di avere manodopera a bassissimo costo: di fronte alla marea di rifugiati siriani Berlino, sospendendo per tre anni le misure che impediscono ai cittadini extracomunitari di occupare posti che potrebbero andare a europei, il governo tedesco si è inventato gli ein-euro-job, lavori socialmente utili pagati un euro l’ora). Alla grande finanza non importa la stabilità di un Paese, né altri “accidenti” come la coesione sociale o la sostenibilità dell’immigrazione sul lungo periodo: l’unico scopo è realizzare il maggior profitto nel minor tempo possibile.

Le esigenze dell’industria vanno invece oltre il contenimento dei salari e si allargano alla necessità di disporre di una manodopera sì qualificata, ma sempre a basso costo. Nel corso degli ultimi decenni la Germania ha attinto ai serbatoi più vicini: quello turco, quello sudeuropeo e quello balcanico.
Per certi versi i tedeschi non hanno fatto altro che applicare la politica di beggar-thy-neighbour anche a livello demografico, realizzando la propria prosperità sulle debolezze altrui: tuttavia, una volta aumentato il benessere nei Paesi di provenienza dei Kanaken (e di conseguenza diminuito il numero di figli pro-capite), la “demovora” si è trovata costretta a cercare carne altrove.
Al “raffinamento” della manodopera proveniente da Turchia, Polonia e Italia è corrisposto infatti un indiscutibile calo degli impiegabili; in particolare l’apparentemente inesauribile fonte ottomana si è prosciugata nel giro di pochi anni: da una media di sessantamila neutralizzazioni all’anno (con un picco di centomila nel 1999 dovuto alla riforma della legge sull’immigrazione), si è passati agli attuali trentamila turchi germanizzati (ancora poco studiato è il fenomeno della Heimkehr da parte degli immigrati sia di prima che di seconda generazione, finora raccontato solo da qualche pellicola un po’ kitsch).
Infine, le esigenze della politica: essa dovrebbe arginare le pretese distruttive della finanza speculativa e dell’industria mercantilistica tentando di tenere assieme la società (o almeno il proprio governo) a colpi di propaganda e ingegneria sociale. Venendo al sodo, la più grande minaccia attuale al modello tedesco è quella demografica: gli studiosi hanno calcolato che con il tasso di fertilità attuale la popolazione della Germania si dimezzerà in meno di un secolo.
Un’alta percentuale d’immigrati (minimo quattrocentomila l’anno) si rende perciò indispensabile a mantenere in piedi un sistema che non sembra poter funzionare in altro modo. Dato che però non esiste in Germania una vera e propria “mediazione” tra interessi contrapposti (perché i politici sono camerieri dei banchieri e i sindacalisti sono camerieri degli industriali), allora l’unica soluzione diventa quella di abbandonare il Multikulti e imporre un feroce monoculturalismo per integrare popoli e identità inconciliabili.
Da tale punto di vista, sorprende il fatto che la Germania sia proprio il Paese meno in grado di integrare gli stranieri: non soltanto per la quantità di foreign fighters che ha fornito alle truppe del sedicente Stato Islamico, ma anche per il fatto che persino popolazioni generalmente laiche e “inquadrabili” come appunto quella turca abbiano covato al proprio interno fenomeni di radicalizzazione sia religiosa che politica (vedi ad esempio i “Lupi Grigi”).
D’altro canto, se chi scappa dalla guerra è attualmente ben disposto (si fa per dire) a svolgere i famigerati “lavori che nessuno vuol più fare” (a un euro l’ora), non è scontato che le seconde generazioni si adattino ordinatamente al “sistema”. I turchi stanchi di essere tedeschi hanno perlomeno una patria a cui far ritorno, dando vita peraltro al curioso fenomeno dei discendenti delle comunità sparse per il vecchio impero ottomano (Bulgaria, Cipro, Grecia, ex-Jugoslavia) che dalla Germania hanno preferito trasferirsi in Turchia piuttosto che tornare nel loro Paese d’origine: non so se si possa configurare come un vero e proprio caso di Deutschenhass, in ogni caso è inquietante osservare come Berlino riesca a dare una caratterizzazione etnica non solo all’immigrazione, ma addirittura all’emigrazione…
Non sembra, per rimanere nell’ambito dei problemi presenti, che i siriani, una volta terminata l’infinita guerra civile, avranno ancora la “fortuna” di ritrovare nazione in cui sono cresciuti e che forse, un tempo, hanno amato. Qui pare proprio che la rodomontata della Merkel abbia acuito il dilemma: ora non si tratta più solamente di sottrarre personale specializzato ai propri concorrenti commerciali, anestetizzando gli orgogli nazionali (altrui) con un europeismo tanto vago quanto frastornante; in questo caso si può parlare addirittura di “colonialismo demografico”, poiché vengono assorbite le energie di un popolo senza nemmeno l’illusione della reciprocità o il supporto di una “religione civile” (contropartita indispensabile, come accennavamo, alla rinuncia a ogni forma di “identitarismo” in una società multietnica).
Che la questione dell’integrazione rappresenti già un’emergenza lo dimostrano anche i frequenti ballon d’essai lanciati in questi anni, come per esempio la proposta di riservare città ad hoc agli immigrati mediorientali (una sorta di “statalizzazione” dell’Heimkehr, per farla accadere entro i confini nazionali?): il promotore del progetto, il verde Kurt Edler, è convinto che “la Germania non ha nessuna identità da offrire”, mentre l’elaboratrice teorica, Ulrike Guérot, crede che imporre una “cultura dominante” agli stranieri sia un atteggiamento “fascista”.
Probabilmente siamo giunti al cuore della “schizofrenia” merkeliana: il continuo ondeggiare tra tolleranza e durezza è un modo per tirare il velo pietoso da una maceria all’altra, cercando di nascondere l’assoluta incompatibilità tra interessi dei lavoratori, della grande industria e dell’altissima finanza.
Il sistema però mostra le sue falle soprattutto a livello sociale, oltre che economico, sia perché la necessità di controbilanciare il cosiddetto “inverno demografico” impedisce una selezione adeguata di manodopera qualificata (la minaccia di una Germania ridotta a 67 milioni di abitanti, per giunta tutti avanti con gli anni, toglie il fiato a quella “selezione all’ingresso” decantata dai politici), sia perché il peso delle recessioni si riversa ciclicamente sulle spalle dei lavoratori stranieri, che anche per questo manifestano il loro malessere con comportamenti antisociali che tuttavia nessuno è oggi disposto a classificare sotto la voce “lotta di classe”.
Per concludere, a fare la storia non sono solo le forze impersonali ma anche quelle “personali”: in tal caso forse nessuno capirà mai davvero cosa sia passato per la mente della Merkel, ma probabilmente con un leader di diverso carisma e intelligenza le cose sarebbero potute andare in altro modo.