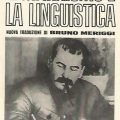Qui sopra due simpatiche letterine a Sergio Romano risalenti allo scorso giugno (prima della Brexit, quindi), in cui si auspicava che sulla scia della Brexit anche l’inglese scomparisse dalle lingue ufficiali dell’Unione. Ovviamente l’ex-ambasciatore non ha potuto far altro che replicare a entrambe “picche” (sorry):
«L’inglese non è soltanto la lingua del Regno Unito. È anche la lingua degli Stati Uniti. Se la City di Londra declinasse, la finanza internazionale parlerebbe pur sempre la lingua di Wall Street».
«La lingua ufficiale degli irlandesi è il celtico, ma pochi lo parlano e tutti usano l’inglese. Toccherà quindi all’Irlanda, se la Gran Bretagna ci abbandona, conservare l’inglese anche formalmente fra le lingue dell’Unione».
Lasciando da parte che il “celtico” è in realtà il gaelico (ma è comunque un bel modo ottocentesco per definirlo) e che l’inglese è lingua ufficiale anche di Malta; veniamo subito al punto: nonostante il tono apologetico assunto in questa occasione nei confronti della Gran Bretagna (che ruleggia sempre, come dice la canzone), il buon Romano ha poi reagito alla Brexit come il protagonista di quell’altra celebre canzone: «Londra era un ostacolo, ora può davvero nascere l’Europa» (“Linkiesta”, 26 giugno 2016).
Se non altro nell’esprimere la sua opinione, il diplomatico è stato meno ambiguo di altri (almeno questo gli fa onore, o forse era proprio un lamento da amante tradito?): continuano però a latitare le considerazioni a freddo dei numerosi aedi della Perfida Albione, che nonostante il profluvio di panzane con cui hanno inondato giornali e televisioni (“La democrazia porta al nazismo”, “Togliamo il diritto di voto ai nonni”, “Adesso in Inghilterra non si possono più usare gli euro”), non hanno ancora chiarito il punto fondamentale: può l’anglofilia essere subordinata all’europeismo? O, per esprimerci in termini che anche i gazzettieri possono capire: Londra buona o cattiva?
Sappiamo che in Italia, per una regola non scritta (o scritta su qualche pergamena nascosta ai comuni mortali), i media nazionali non possono parlar male degli inglesi; anzi, ogni telegiornale deve dedicare almeno tre servizi a settimana alla regina Elisabetta e ai suoi fottutissimi parenti. Insomma, non è possibile indire un referendum per abolire l’influenza della monarchia inglese nel nostro Paese. Va bene così, tanto si sa che con Albione non si può mai giocare ad armi pari. Però ora la questione si pone: se dobbiamo morire per Bruxelles, per l’eurocrazia e per la moneta unica, potremmo almeno tagliar corto con questa anglofilia da mentecatti?
Tornando alla questione della lingua, anche se la diffusione dell’inglese “ciancicato” ha precedenti inquietanti, non si può negare che l’anglicizzazione nasca principalmente da necessità pratiche, soprattutto quando declinata in termini di “americanizzazione”. Pensiamo, per esempio, al recente dibattito sorto dalla “smania inglese” dilagante nelle nostre università: essa genera comprensibili timori in quelli che la vedono come un cedimento al pensiero unico o alle mode intellettuali. Alcuni critici rilevano peraltro che nella nostra realtà lavorativa l’inglese non è una lingua più richiesta di altre, dal momento che l’Italia non può campare semplicemente come “villaggio turistico del mondo” (in tal caso basterebbe solo un po’ di anglicorum), ma per sopravvivere ha bisogno di una mediazione culturale di più alto livello, sia per consolidare la sua vocazione esportatrice che per integrare efficacemente i numerosi stranieri presenti sul territorio.
Credo esista un motivo di fondo, non del tutto esplicitato, di questa improvvisa necessità di “anglicizzarsi”, e riguarda il declino delle facoltà umanistiche statunitensi in atto da decenni, descritto impietosamente da Allan Bloom in The Closing of the American Mind (1987).
Dal punto di vista educativo il nostro Paese può vantare, in diversi campi, eccellenze in grado di attrarre migliaia di studenti stranieri: sembra quindi che tale scelta sia dettata anche dall’esigenza di intercettare l’enorme massa di giovani provenienti dalle economie emergenti che cominciano a diffidare di un’educazione “all’americana”. Osservando la situazione da questa prospettiva, si comprende anche come il pericolo più grande non sia tanto l’americanizzazione linguistica, quanto quella culturale (che tra l’altro si potrebbe portare a compimento anche solo utilizzando la lingua italiana, come dimostrano i vari studi culturali, studi di genere ecc.).
Dunque non c’è solo la lingua di Wall Street o della Polizia del Kansas City. O, per meglio dire, queste possono sicuramente fornire un adeguato supporto nell’ipotesi assurda che a difendere l’ufficialità dell’inglese nell’Unione Europea rimanga solo Malta (con l’Irlanda impegnata a valorizzare il “celtico” per motivi irredentistici); ma pure in tal caso l’imposizione di una nuova lingua franca non consentirebbe di eludere alcune dinamiche obbligate.
Per concludere finalmente con l’amato idioma gentile, vogliamo ricordare che, di fronte al pericolo della sua scomparsa o di una riduzione a dialetto, Vincenzo Cerami sostenne che i suoi connazionali avrebbero dovuto esportare di più («chi esporta più prodotti esporta più lingua»), oppure accettare di «diventare una colonia americana», perché se «è finito il latino, è finito il provenzale, pazienza: finirà anche l’italiano». (cfr. “I Paesi più forti esportano insieme alle merci anche il loro vocabolario”, Il Messaggero, 26 settembre 1989; ora in Pensieri così, Garzanti, Milano 2002, p. 93).
A dispetto di tali asprezze, è tuttavia necessario ricordare che nei secoli uno dei “prodotti” nostrani più esportati è stato proprio la lingua italiana, attraverso l’arte, la letteratura, la navigazione, l’architettura, il teatro: lo prova, tra le altre cose, il vocabolario che i musicisti di tutto il mondo (anche quelli americani) sono costretti a utilizzare. Di conseguenza, almeno per gli orchestrali dell’apocalisse varranno ancora il motto: «Il giorno della fine non ti servirà l’inglese».