
Papa Francesco sostiene che la Terza Guerra Mondiale sarebbe già cominciata, ma che per ora la si stia combattendo “a pezzetti” (sic). Alcuni intellettuali neoconservatori invece sostengono che la Terza Guerra Mondiale sia già stata vinta dall’Occidente nel 1989 con il crollo del Muro di Berlino, e che adesso ci troveremmo in mezzo alla Quarta, quella contro l’islam (o l’islamofascismo o l’islam politico). Probabilmente qualcuno, da qualche parte del mondo, or ora starà dicendo che pure la guerra contro l’islam è vinta e che adesso ci aspetta una Quinta Guerra Mondiale tra USA e Cina o Russia, ecc…
La questione non è così di lana caprina come potrebbe apparire: il nome con cui ci si riferisce a una guerra è rivelatorio dei criteri con cui la si interpreta. È per questo che i russi chiamano “Grande guerra patriottica” la Seconda Guerra Mondiale e che il parlamento ucraino ha vietato di utilizzare l’espressione come parte di una serie di norme per favorire la decomunistizzazione definitiva del Paese. Per un motivo simile, nelle aule scolastiche italiane fino a pochi decenni fa la Prima Guerra Mondiale veniva presentata come “Quarta guerra d’indipendenza”, prima che prevalesse la lettura unilaterale del conflitto quale inutile strage, prendendo a prestito la celebre espressione di Benedetto XV dell’agosto 1917.
La nostra analisi potrebbe partire da questa “appropriazione indebita” delle parole di un Pontefice: senza nulla togliere alla loro nobiltà e coraggio, è innegabile che le istituzioni europee (non solo quelle italiane), in questi anni di quadruplicazione del “centenario” della Grande Guerra, abbiano approfittato della definizione di “inutile strage” più per motivi di propaganda post-nazionalistica (l’Europa-Nazione come espressione di un nazionalismo alternativo e benevolo) che per un sincero mea culpa.
Una conseguenza di tale negazione di senso è l’attuale propensione a interpretare qualsiasi avvenimento come prodromo a un nuovo conflitto mondiale. Anche in questi giorni si è potuto riscontrare come una insignificante esercitazione NATO (Anakonda) sia riuscita a ispirare gli ennesimi voli pindarici dei cosiddetti “esperti di geopolitica”. La paranoia del “gesto eclatante” è del resto diffusa a tutti livelli; in una rivista storica patrocinata dalla BBC, uno storico come Christopher Clarke trovò il coraggio di scrivere questo:
«L’assassinio di Sarajevo è presentato in molti resoconti come un pretesto, un evento poco legato alle forze reali, la cui interazione scatenò la guerra. La verità è che l’omicidio dell’arciduca presentò alle autorità austro-ungariche una sfida che esse non poterono permettersi di ignorare. Per trasmettere il senso della gravità della situazione nella prospettiva di allora, dobbiamo semplicemente chiederci come risponderebbero oggi, ad esempio, gli Stati Uniti di fronte all’assassino di un presidente eletto e di sua moglie da parte di un commando addestrato a Teheran» (C. Clarke, Lo sparo che fece 10 milioni di morti, “BBC History”, n. 20, dicembre 2012, p. 49).
Se almeno gli italiani continuassero a chiamare la Grande Guerra “Quarta guerra d’indipendenza”, forse avrebbero più ritegno nello strologare sulla prossima. Soprattutto perché –ora veniamo al punto– nel mondo d’oggi non esiste più (o non ancora) luogo in cui combattere questa benedetta “Guerra Mondiale”.
Sul Pianeta Terra, l’habitat elettivo di ciò che chiamiamo “guerra mondiale” è notoriamente l’Europa: se per assurdo in questo istante scoppiasse un conflitto tra Cina e Giappone e intervenissero americani e russi, tutto ciò non potrebbe essere definito ancora “guerra mondiale”. Non è una lettura eurocentrica, tanto è vero che pure gli attori principali del nostro evo sembrano averne una qualche istintiva consapevolezza (forse è anche per questo che, nonostante le migliaia di pretesti, Pechino e Tokyo non sono ancora “venuti alle mani”).
Uno degli autori che ha tentato di comprendere tale condizione è stato Carl Schmitt: pur con i suoi limiti, egli è riuscito a fornire una previsione verosimile di cosa sarebbe stata la guerra in un’epoca di dopoguerra (in senso assoluto). Tuttavia il filosofo è riuscito soltanto a intravedere, senza capire fino in fondo: non per limiti di prospettiva o intelligenza, ma probabilmente per i segni che la sconfitta tedesca ha lasciato nel suo animo.
Per cominciare, partiremmo da un tema apparentemente secondario, che tuttavia compare con una certa frequenza nell’opera del giurista tedesco: quello del “pianeta misterioso”. Si tratta di un pregevole tentativo di “guardare oltre” che per vari motivi non è mai stato approfondito, e anzi è rimasto circoscritto a una boutade nella “Presentazione” a Il nomos della terra (tr. it. E. Castrucci, Adelphi, Milano, 1991, p. 15):
«L’ordinamento eurocentrico finora vigente del diritto internazionale sta oggi tramontando. Con esso affonda il vecchio nomos della terra. Questo era scaturito dalla favolosa e inattesa scoperta di un nuovo mondo, da un evento storico irripetibile. Una sua ripetizione moderna si potrebbe pensare solo in paralleli immaginari, come se ad esempio uomini in viaggio verso la luna scoprissero un nuovo corpo celeste finora del tutto sconosciuto, da poter sfruttare liberamente e da utilizzare al fine di alleggerire i conflitti sulla terra. La questione di un nuovo nomos della terra non può trovare una risposta in siffatte fantasie».
È deplorevole che una intuizione così promettente venga liquidata come “fantasia”. Invece di lasciarla cadere, Schmitt avrebbe dovuto perlomeno collocare questo “nuovo corpo celeste” in un punto specifico della sua filosofia: si tratta di un pianeta disabitato, che replica la «comparsa di spazi liberi immensi» fornendo le basi a un rinnovato Jus Publicum Europaeum? Oppure è un satellite popolato da alieni, la cui comparsa, al pari di una hegeliana astuzia della Ragione, offre finalmente ai terrestri la possibilità di dare un senso alla parola “umanità” al di là della criminalizzazione del nemico?
Non sono soltanto divagazioni, poiché se qui Schmitt sembra avvalorare l’ipotesi di una res nullius intergalattica, in altro luogo lo stesso corpo celeste ricompare, questa volta abitato:
«L’umanità in quanto tale non può condurre nessuna guerra, perché essa non ha nemici, quanto meno non su questo pianeta» (Le categorie del “politico”, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 139).
Anche nella suggestiva Teoria del partigiano (cur. F. Volpi, Adelphi, Milano, 2005, pp. 111-112) l’Autore avanza timidamente l’idea di una “dimensione interplanetaria” del conflitto, senza però accennare nemmeno alle caratteristiche del “cosmo-partigiano” (di cui invece tratta il compianto Franco Volpi nella postfazione).
In effetti è curioso che a un certo punto Schmitt non si sia messo a parlare di “corsari dello spazio” (nonostante egli proponga il parallelo tra guerra partigiana e privateering, nonché tra il partigiano e il sottomarino [p. 77]) o di uno Jus Publicum Universale generato dal nuovo equilibrio terra-mare, declinato nel senso di “Terra” come pianeta e “Mare” come spazio intergalattico.
Pare sia stato proprio un certo risentimento da “vinto” a impedirgli di riconoscere queste analogie, attraverso le quali avrebbe indirettamente conferito una qualche nobiltà alla nostra epoca; in certi passaggi la sprezzatura emerge chiaramente:
«All’ombra dell’odierno equilibrio atomico delle potenze mondiali, sotto la campana di vetro, per così dire, dei loro giganteschi arsenali distruttivi, potrebbe ritagliarsi uno spazio destinato alla guerra limitata e circoscritta condotta con armi e perfino mezzi di distruzione tradizionali, sul cui dosaggio le grandi potenze potrebbero apertamente o tacitamente accordarsi. Questo provocherebbe una guerra controllata da quelle potenze, e sarebbe una specie di dogfight» (Teoria del partigiano, pp. 110-111).
Idealizzare il “modello Vestfalia” come l’unico in grado di limitare la guerra e nel contempo farsi beffe del nuovo equilibrio internazionale perché parla inglese e russo (invece che tedesco) è una posizione intellettualmente poco onesta. Carl Schmitt, che si vuole così “spregiudicato” nelle sue analisi (tanto da essere definito da taluni come “il Nietzsche della filosofia politica”), non è immune da una certa Romantik: la sua concezione idillica del “legame con la terra”, per esempio, lo porta a descrivere con toni patetici l’azione di un esercito di terra che manterrebbe «una relazione positiva con il territorio occupato e con la sua popolazione» (Il nomos della terra, p. 424), in contrapposizione alla flotta che agirebbe invece “di forza” e “coartivamente” (per non dire del Partigiano raffigurato quale “eroe tellurico”, un altro eccesso di idealizzazione che sembra compensare le ingenue considerazioni a cui abbiamo accennato).
Dopotutto, ciò che ancora chiediamo a Schmitt (senza però ricevere risposta) è di indicare un theatrum belli consono all’era atomica. Nella sua “teoria degli elementi”, accanto a Terra e Mare, e all’Aria (che interviene a spezzare l’equilibrio), manca il Fuoco. Stiamo parlando non solo del fuoco della contraerea che riporta la cosiddetta “guerra aerea autonoma” a una dimensione orizzontale del conflitto, ma anche di un altro tipo di fuoco, quello nucleare, che dopo l’agosto 1945 non è più stato “riacceso”. Come è stato possibile?
In questo campo abbondano non solo le spiegazioni provvidenzialistiche (soprattutto da parte degli atei), ma anche quelle che filosoficamente potremmo definire anti-timotiche, riassumibili nella formula “equilibrio del terrore”: improvvisamente, gli uomini sarebbero diventati tanto razionali, sensibili e pacifici, da riuscire a fermarsi a un passo dall’apocalisse. Questa interpretazione, oltre a essere al contempo ottimistica e demoralizzante (perché toglie all’essere umano sia il coraggio che l’incoscienza), contraddice la fondamentale legge di Murphy: «Se qualcosa può andar male, lo farà». Volendo tuttavia accettare un’evoluzione inspiegabile nella coscienza della specie, dovremmo comunque riconoscere che a impedire l’apocalisse nucleare durante la Guerra fredda non contribuirono solamente l’equilibrio del terrore o la “lotta tra cani”.
Se avessimo una sensibilità hegeliana, potremmo affermare che l’atomica sia comparsa nella storia al momento giusto, ovvero in concomitanza con le prime spedizioni nello spazio. In tal modo diventerebbero ancora più plausibili le analogie tra l’oltremare, «un campo in cui si afferma il libero e spietato uso della violenza» (Il nomos della terra, p. 93) e l’oltrespazio, o ancora meglio tra la scoperta delle Americhe, che «servì […] a limitare la guerra europea» (ivi, p. 98) e la colonizzazione di nuovi pianeti.
L’elemento del “fuoco” potrebbe dunque scatenarsi nello spazio intergalattico, l’unico luogo fisico in cui sia lecito atomizzare l’avversario senza condurre una guerra di sterminio? Tutto sommato questo potrebbe essere quasi un “lieto fine” (si fa per dire): il Pianeta Terra, divenuto una confederazione universale di nazioni (o di agglomerati sovranazionali), “scaricherebbe” il conflitto tra la Luna, Marte e Urano (ma chi si azzarderebbe a colonizzarlo per primo?).

Qualcosa tuttavia non torna. È vero, infatti, che gli uomini non hanno smesso di farsi la guerra: sembra anzi che l’aspirazione a costituire enormi raggruppamenti di Stati su modello delle superpotenze orwelliane (Eurasia, Estasia e Oceania) rappresenti inconsciamente il desiderio di creare lo spazio bellico adatto alla guerra atomica.
Inoltre continua a sussistere l’obbligo di individuare un “nemico assoluto” su cui finalmente replicare Hiroshima e Nagasaki in grande stile. Per certi versi, l’Isis è comparso al posto giusto e al momento giusto, anche se più che a un agnello sacrificale assomiglia al famigerato pollo del gioco delle tre carte: tanto è vero che, senza turbare i sonni dei pacifisti, i russi stanno sperimentando sugli improvvisati jihadisti le armi più micidiali che si possano utilizzare prima di quelle atomiche.
È un fatto tuttavia che chi detiene (almeno per il momento) la superiorità tecnologica in campo bellico non potrebbe analogamente gloriarsi di adoperare armi del genere: non solo perché la “copertura” umanitaria è svanita nel brevissimo passaggio da un millennio all’altro (1999-2001), ma anche perché dopo un decennio di “inutili stragi” (questa volta la definizione calza a pennello), di Vietnam replicati più per motivi ideologici che strategici, gli Stati Uniti si sono ridotti a trovare l’unico spazio bombardabile nel deserto siriano (anche qui, bisogna notare che l’Isis ha scelto poco intelligentemente di “territorializzarsi” in uno dei luoghi attualmente più suscettibili di nuclearizzazione, al pari delle foreste asiatiche e delle distese artiche).
Col nuovo secolo è emersa altresì una tendenza inedita nell’inconscio collettivo, soprattutto grazie alla piena diffusione di internet: la necessità di catalogare tutto l’esistente per conservarlo in eterno. Già ai tempi dell’intervento NATO nei Balcani diversi commentatori paventarono la minaccia dei bombardamenti per alcune specie protette della flora e della fauna locali (non parlavano di umani): ricordo che venne persino avanzata la proposta di clonare gli animali a rischio di estinzione (erano i tempi della Pecora Dolly).
Oggi che queste tecnologie si fanno sempre più “democratiche”, la catalogazione è divenuta quasi un obbligo: si vedano per esempio gli scienziati siriani che all’inizio della guerra civile hanno provveduto a inviare tutte le sementi nazionali allo Svalbard Global Seed Vault, oppure all’impegno assunto da alcune imprese (anche italiane) di restaurare i monumenti distrutti dall’Isis per mezzo di stampanti 3D. Non è da escludere in futuro l’eventualità che, una volta nuclearizzato un Paese, l’aggressore venga poi costretto dallo “spirito dei tempi” a ricostruirlo esattamente com’era.
Per tirare le somme (e non le cuoia): l’unica Terza guerra mondiale che può essere definita come tale dovrebbe essere combattuta in Europa, ma ciò, almeno nella pratica, è –quasi– impossibile; di conseguenza le superpotenze ricorrono a ogni tipo di espediente nell’attesa che finalmente emergano degli “spazi nuovi” in grado di garantire un theatrum belli per la guerra atomica (questo potrebbe forse spiegare la tendenza attuale di alcuni Stati ad agglomerarsi, per garantire una “periferia” annichilabile a fronte di un “centro” da salvaguardare).
Quindi, per citare un titolo azzeccato, La fin du monde n’est pas pour demain: nel caso dovessi sbagliarmi, sono in debito di una birra.







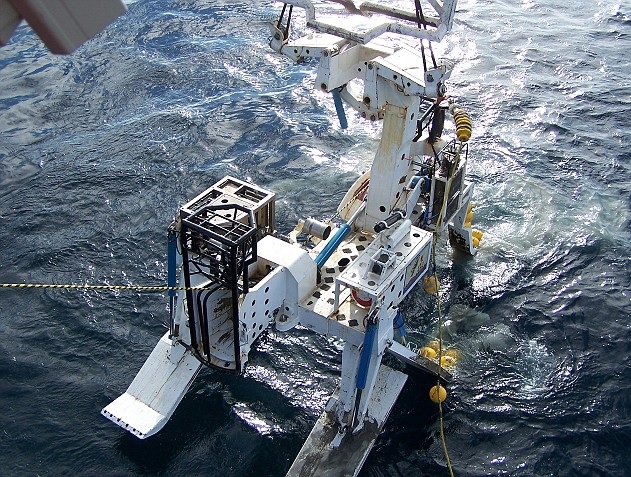
Cmq sull'”inutile strage” c’è chi afferma che se si fa un profondo lavoro filologico ed esegetico si può arrivare a interpretare l’uso di quell’appellativo non tanto riferito alla prima guerra mondiale in sè ma alla modalità della guerra ossia la guerra di trincea/posizione. Confido in un tuo parere su ciò.