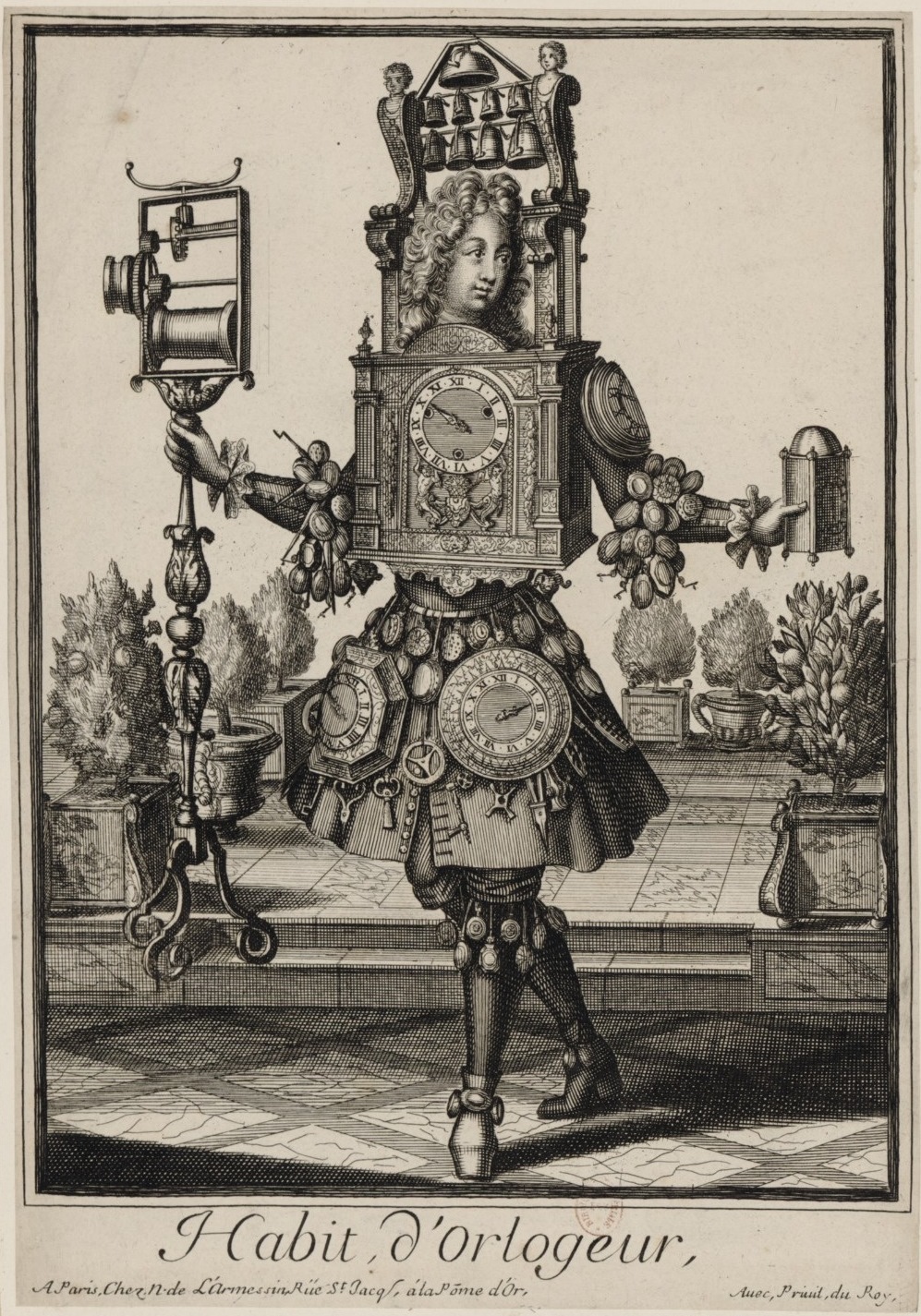Queste rapide osservazioni sulla fine della storia sono ispirate a un breve saggio di Jacob Taubes, Estetizzazione della verità nella post-storia, una “nota di una nota” nella quale il rabbino cita Alexandre Kojève before it was cool, cioè un attimo prima che il filosofo franco-russo diventasse malgré lui uno dei padri putativi del pensiero neoconservatore. Lo “sdoganamento”, come è noto, seguì alla riduzione ad usum Delphini proposta da Francis Fukuyama nel suo fortunato saggio La fine della storia e l’ultimo uomo.
Ciò che in realtà Taubes si limita a fare è presentare al pubblico tedesco una nota a piè pagina dell’Introduction à la lecture de Hegel, (tradotto in italiano, ça va sans dire, da Adelphi) incredibilmente “bucata” nell’edizione Suhrkamp. Non ho elementi per comprendere se tale omissione sia volontaria o meno, ma è comunque sorprendente che manchino proprio i passaggi sui quali Fukuyama ha imbastito quasi tutte le sue tesi.
Peraltro mi accorgo soltanto “col senno di poi”, proprio grazie a Taubes, come anche il politologo nippo-statunitense abbia provveduto a glissare sulle conclusioni di Kojève, fermandosi per convenienza al momento in cui il Maestro sostanzialmente afferma che America e Russia pari sono:
«Se gli Americani fanno la figura di cino-sovietici arricchiti, è perché i Russi e i Cinesi non sono che degli Americani ancora poveri, anche se in via di rapido arricchimento».
Infatti, se la memoria non m’inganna (al momento non ho il volume sottomano), ricordo che Fukuyama non accenna mai al viaggio in Giappone (1959) di Kojève, nonostante tale esperienza indusse il filosofo non solo a ritrattare le precedenti conclusioni, ma addirittura a elaborare un nuovo modello nippo-centrico (!) della “fine della storia”:
«L’interazione recentemente avviata in Giappone e il Mondo occidentale sfocerà, in fin dei conti, non in nuovo imbarbarimento dei Giapponesi, bensì in una “giapponesizzazione” degli Occidentali (Russi compresi)».
Fukuyama al contrario ipotizza che Kojève individui la “istituzionalizzazione della fine della storia” nella Comunità Europea, deducendolo solo dal fatto che negli ultimi anni della sua vita vi collaborò in qualità di burocrate (un dettaglio che in verità i biografi smentiscono categoricamente). È forse possibile che la “giapponesizzazione” del Vecchio Continente coincidesse, nel pensiero di Kojève, con una “burocratizzazione”, cioè una formalizzazione totale dell’agire politico? Una cosa può non escludere l’altra, ma Fukuyama elude completamente la questione; in compenso, Taubes individua senza esitazioni il nocciolo del dilemma:
«Kojève modifica il suo concetto di post-storia (1955) in seguito a un viaggio di Giappone, che gli mostra un’altra via alla post-storia: lì la nobiltà rinuncia la rischio della vita e al lavoro, senza tuttavia divenire animalesca. Essa coltiva il suo puro snobismo. Invece di rischiare la vita nella lotta, l’hanno elevata a cerimoniale, cosicché ciascuno nella propria posizione “è in grado di vivere secondo valori totalmente formalizzati, cioè completamente privi di qualsiasi contenuto umano, cioè ‘storico’”. Così si dà per Kojève una possibilità dell’esistenza nella post-storia esattamente opposta allo stile americano: invece della ri-animalizzazione, un’apoteosi conclusiva dell’ultima forma storica, senza contenuto, un’affermazione dell’apparenza rimasta della storia e della verità senza sensi di colpa, un’estetizzazione senza riguardi».
Trovo singolare che tra i sempre più numerosi esegeti di Kojève, nessuno abbia ancora provato a rileggerne l’opera partendo da tale conclusione seconda. È vero, la visione di una definitiva omogeneizzazione tra Gog e Magog in funzione appunto dell’Universal and Hhomogeneous State è talmente affascinante da attrarre su di sé tutte le attenzioni: la rivalità mimetica cosmica che conclude l’avventura umana quale l’abbiamo conosciuta finora, l’apocatastasi della storia, della filosofia e dell’autocoscienza e il ritorno all’arte all’amore e al gioco come pratiche puramente istintive offrono infiniti spunti di dibattito:
«Dopo la fine della Storia, gli uomini costruiranno i loro edifici e le loro opere d’arte come gli uccelli costruiscono i propri nidi e i ragni tessono le proprie tele, eseguiranno concerti musicali alla maniera delle rane e delle cicale, giocheranno come giocano i giovani animali e si daranno all’amore come fanno le bestie adulte».
Certe suggestioni sono passate persino nella cultura popolare, come emerge da una fantasmagorica recensione di Full Metal Jacket del critico Giuseppe Rausa:
«Nell’episodio conclusivo […] la donna-cecchino mostra di aver imparato che la lotta è totale e va combattuta senza esitazioni (si pensi a come infierisce sui corpi feriti delle sue vittime) mentre nel suo bunker si nota una bandiera del Vietnam del nord: in essa il rosso, il blu e una stella ci raccontano la stretta parentela con quella USA. Infatti la bandiera americana fu la prima ad adottare la stella come simbolo di libertà e indipendenza, nonché come segreta allusione al carattere massonico del nuovo Stato […]; la stella, attraverso lunghe migrazioni, diviene anche un simbolo dell’Urss (disegnata, color oro, sul rosso fondale) e da lì, attraverso la Cina, giunge al Vietnam del nord (ancora color oro su fondo rosso e blu). Il comunismo, versione estrema dell’ideale ugualitario delle logge, è in definitiva un parente stretto, seppur radicale, e perciò fortemente illiberale, del repubblicanesimo massonico nel quale invece almeno la libertà individuale è conservata […]. Così gli Stati Uniti combattono contro regimi comunisti che costituiscono una sorta di degenerazione dei loro ideali, insomma dei “cattivi cugini”».

Tuttavia, questo non è Kojève, o perlomeno è un non-Kojève (alla pari dei “non metalli” che traggono la loro definizione da una negazione): nella conclusione seconda l’accesso alla post-storia non è più garantito dall’American way of life, «il futuro “eterno presente” dell’umanità intera», ma dal rigido ritualismo giapponese, emblema di
«una società unica nel suo genere, perché è la sola ad aver fatto un’esperienza di vita lunga quasi tre secoli in epoca di “fine della Storia”, cioè in assenza di ogni guerra civile o esterna».
Certo, questa stereotipizzazione estrema della società nipponica, che ricorda l’esterofila ingenua del turista appena tornato dalle vacanze («Tutti i Giapponesi, senza eccezione, sono attualmente in gradi di vivere in funzione di valori totalmente formalizzati, cioè completamente privi di qualsiasi contenuto “umano”, nel senso di “storico”»), può forse aver fatto arricciare il naso ai chiosatori, in particolare a quelli italiani, che probabilmente hanno preferito liquidarla appunto come l’esaltazione del parente appena tornato da Londra, Barcellona o Zurigo (sì, anche Zurigo), oppure usando le parole di Pippo Franco a commento del seppuku di Yukio Mishima: Ma che me frega a me der grande Giappone (Karakiri, 1971).
Se è solo in parte giustificabile un’omissione “in buona fede”, diverso è il caso di chi continua a declinare le idee di Kojève in una dimensione esclusivamente nichilistica. Esiste un altro Kojève (potremmo definirlo, per restare in linea, un post-Kojève) il quale sostiene che il coup de grâce alla storia non verrà dato da un’artefatta discesa verso il bestiale e l’amorfo, ma dalla perfetta coincidenza tra Regno della Necessità e Regno della Libertà.
A questo punto, non pare azzardato sostenere che tale uscita “verso l’alto” dalla storia, o almeno dall’hegelismo (o da quell’hegelismo per le masse che il marxismo), abbia molti aspetti in comune con una escatologia.
È chiaro che, portando Kojève all’estremo, nell’“estetizzazione” di cui parla Taubes (ancora in senso nichilista, ma di un nichilismo intellettualmente più onesto), si giunge al paradosso di una immortalità puramente fisica, immanentistica (si veda L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares, rappresentazione plastica del dilemma).
Forse non è del tutto vero che un rituale valga l’altro, nell’impresa prometeica dell’Uomo post-storico di «staccare le “forme” dai loro “contenuti”»: altrimenti non sarebbe nemmeno saltato fuori il Giappone al momento opportuno. Salus ex Japonicis est? Non voglio nemmeno pensare a quali conclusioni sarebbe giunto il buon Taubes se avesse fatto in tempo a leggere il best-seller di Isaia Ben-Dasan (al secolo Shichihei Yamamoto), The Japanese and the Jews, dove si dimostra la perfetta corrispondenza tra i due popoli…