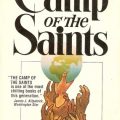È difficile restare aggiornati sul dibattito francese senza trovarsi nei panni dei cugini d’oltralpe (mi pare che una volta li chiamassimo così): non si capisce, per esempio, se tutti questi intellettuali dal piglio pseudo-maurassiano, già bollati come néo-réacs (“populisti” in Italia), facciano sul serio. Se ne potrebbero elencare decine, ma è meglio di no. Ci limitiamo a sottolineare che mentre le bordate anti-euro nel nostro Paese sono lasciate a politici di livello non eccelso, in Francia invece partono direttamente da studiosi che si professano ancora gauchiste: a parte l’onnipresente Michel Honfray (che tra l’altro ha dato dello stronzo a BHL, quindi non può essere del tutto malvagio), il sempreverde Emmanuel Todd ha addirittura teorizzato un anti-europeismo di sinistra in un suo recente volume (Qui est Charlie?, 2015) ponendo sotto accusa il blocco sociale del MAZ (classes Moyennes, personnes Âgées, catholiques Zombies) per i quali l’euro è la monnaie unique qui a remplacé le Dieu unique (non male).
Come detto, è superfluo fare il conteggio di chi era già “cattivo” (come Pascal Bruckner, Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour…) e di chi lo è diventato (la lista non sarebbe meno lunga: Régis Debray, Jean-Pierre Le Goff, Jean-Claude Michéa, Jacques Sapir…). L’importante è comprendere se questo accenno di egemonia culturale lepeniana servirà poi al Front National per arrivare alla presidenza, o se ancora una volta verrà utilizzato dagli elettori francesi per intimorire i componenti del “patto repubblicano” e portarli a più miti consigli in tema di lavoro, welfare e immigrazione.
E se ci trovassimo invece al cospetto di una vera “rivoluzione culturale”, come dovremmo comportarci? In primo luogo è necessario comprenderne le cause. Se appartenessimo alla gauche caviar potremmo senza indugio attribuire la metamorfosi all’imbarbarimento e all’ignoranza dilagante: senza il moralismo di cui è intrisa (e che ipocritamente nasconde), tale tesi potrebbe anche avere un senso. In effetti oggi quello che definiamo a seconda dei casi “inconscio collettivo”, “intelletto agente”, noosfera (ognuno lo chiami come vuole) è stato pesantemente influenzato dal nuovo mezzo di comunicazione, internet, che ha fatto piazza pulita di tutto quanto esisteva al di fuori di se stesso.
Piuttosto che perdersi in discussioni sull’utilità e il danno di internet per la vita (e domandarsi quindi se Internet ci rende stupidi? come il titolo di un fortunato saggio di qualche tempo fa) bisognerebbe semplicemente limitarsi ad analizzare come il mezzo agisce a livello collettivo (evitando i toni da technological idiot): dovremmo, ad esempio, considerarlo una “sorgente di iconoclasta perpetua” oppure includerlo nel novero dei vari miti che l’umanità si è imposta nel corso della sua storia? Di primo acchito pare che nemmeno i vari social network riescano a conferire l’autorevolezza che un tempo elargivano ben altre strutture: basta osservare come li utilizzano i politici (stendiamo un velo pietoso sulla situazione italiana).
È innegabile quindi che persino gli intellettuali, soprattutto quelli che ambiscono a una qualche visibilità pubblica, si sentano spinti dalla pressione di internet a ridurre all’essenziale il proprio pensiero. Questo è un approccio non inedito alla tecnologia, se pensiamo quando agli albori del secolo della tecnica i futuristi rifondarono le arti in base agli “elementi essenziali della sensibilità plastica” (come afferma uno dei loro manifesti). Emerge dunque nuovamente una tendenza alla “stilizzazione” delle opinioni, che spesso (persino casualmente) si innesta sulle idées reçues del momento.
Potremmo addirittura dedurne che tutte le avanguardie (a parte la prima, homicida erat ab initio) sono obbligate a essere “reazionarie” (soprattutto perché l’establishment è sempre rappresentato dalla precedente generazione di rivoluzionari); il discorso però ci porterebbe troppo lontano, anche se sarebbe affascinante capire che cosa indusse Tristan Tzara nell’immediato dopoguerra a identificare nell’Unione Sovietica il modello di un mondo nuovo “dove la vita sarà degna di essere vissuta per tutti gli uomini” (cfr. la serie di conferenze Le surréalisme et l’après-guerre, 1947). Tuttavia ciò, come detto, ci obbligherebbe a divagare troppo.
Veniamo al punto: il pericolo più grande dei nostri tempi non è il colore della forza politica che si troverà a gestire la decadenza europea (della quale parliamo da quasi due secoli), quanto la terribile puzza di “interregno” che emanano le macerie delle nostre istituzioni. Come dimostra uno dei libro meno anti-utopistici pubblicato nel nostro evo, The Great Big Book of Horrible Things (tradotto come Il libro nero dell’umanità da Ponte alle Grazie nel 2011, ma già fuori catalogo) le più atroci catastrofi dell’umanità avvengono nei periodi di transizione tra una forma di potere e l’altra.
Per capirlo non serve nemmeno leggersi il libro: basta aver seguito l’evoluzione dei fatti libici negli ultimi cinque anni, che smentiscono per esempio l’opinione di una ex-amazzone di Gheddafi, oggi attivista per i diritti umani, la quale al “Corriere” ha dichiarato che «la censura imposta dalla dittatura dà sempre la falsa impressione della quiete. Adesso pare peggio perché nessuno censura i media. La Rete è aperta a tutti. In verità oggi è ancora molto meglio di ieri» (L. Cremonesi, L’amazzone pentita di Gheddafi, 8 giugno 2014).
Ovviamente arrendersi ai “fatti” (cioè all’interpretazione che diamo di ciò che identifichiamo come “fatto”) non è di per sé una cosa buona, ma anche volendo dare moralmente ragione all’attivista libica, dovremmo constatare che ormai più nessuno, se non qualche sparuta élite, condivide questi principi: persino il legittimismo artefatto di un Gheddafi viene anteposto a qualsiasi entusiasmo rivoluzionario (la polemica Onfray-BHL di cui sopra ne è una dimostrazione). Forse è questa una della manifestazione più genuine della nostra fin de siècle (contraddistinta anche dall’indolenza con cui si presenta).
Tale è il rischio dell’ultima reazione: che essa non abbia nulla a che fare con la verità. Dopo aver occultato il nichilismo per lungo tempo, ora la destra deve fare i conti con esso non più come convitato di pietra, ma in quanto presenza costante nell’agire quotidiano. Nascerà forse una politica all’insegna del brutalismo, per mutuare un termine dall’architettura)?
Un amico mi propone spesso il paragone con un episodio dell’Andrej Rublëv di Tarkovskij, quello “della campana”: il figlio di un fonditore di campane (Boriska) in seguito a un’epidemia di peste rimane l’unico in grado di realizzarne una per il duca, che nel caso non sarà soddisfatto gli farà tagliare la testa. Il giovane fa credere a tutti di conoscere il segreto della fusione confidatogli dal padre prima della morte, ma in realtà alla fine si scopre che egli è riuscito nell’impresa solo perché ci ha creduto. Non dico che Boriska fosse “brutalista”, ma c’è qualcosa che accomuna tali percorsi e che in un’altra epoca avremmo definito provvidenziale. In ogni caso anche per i pessimisti c’è un dato positivo: la possibilità di osservare tutto questo in vitro, considerando la palude che è diventata l’Europa. In fondo anche una uscita brutalista dalla modernità sarà pure sempre una farsa…