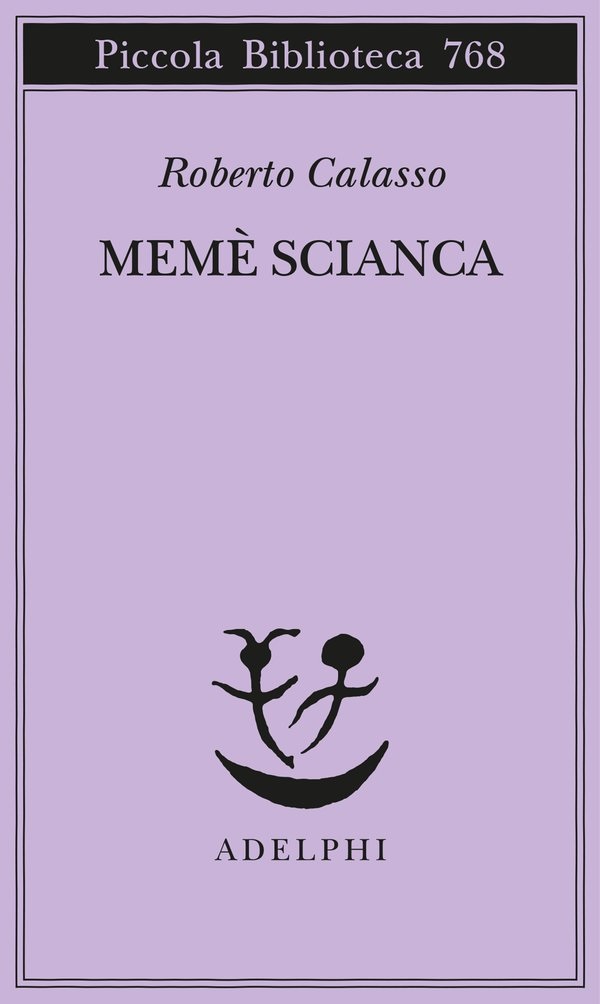
Come presumo abbiate fatto anche voi, pure io sono corso a leggermi Memè Scianca di Roberto Calasso, le memorie dell’editore-sciamano pubblicate da Adelphi esattamente nel giorno della scomparsa (mossa di marketing estremo o manifestazione delle forze sottili, comunque una coincidenza significativa da far impallidire lo Jung). L’autobiografia minima di “Memè Scianca” (nomignolo infantile scelto dall’Autore, tramite l’unione del soprannome del barone di Charlus e della versione induista delle trombe di Gerico, lo shankha) si potrebbe recensire a vari livelli, come manifesto di una élite-non-élite che nell’Italia repubblicana ha potuto avvalersi solo della Cultura (“Zivilisation” in tedesco *occhiolino occhiolino*) per garantirsi una superiorità ormai non più accessibile attraverso il potere (inteso in senso essoterico), il censo o il denaro. Si tratterebbe in effetti dell’unica lettura onesta da parte dei non iniziati, che tuttavia proprio perché tali si lasciano affascinare da qualsiasi creatura partorita, o per meglio dire emanata, dalla macchina editoriale più stupefacente di questi decenni. Una interpretazione da metter perciò da parte (ché come giornalista onesto sarei in ogni caso un reietto, e tanto vale quindi scrivere quel che mi pare), in favore di una riduzione ai minimi termini delle memorie calassiane già di per sé ridotte al minimo (in ossequio al concetto fisico del principio di minima azione, cioè alla feroce forza [che] il mondo possiede).
Si parte dalla letteratura come glossa, “idea di uno scritto che nasce da un altro scritto” e che nei commentari allineati come spire del serpente nasconde l’insensatezza delle origini. Il piccolo Calasso lo deduce osservando il padre Francesco, decano del diritto comune nell’Italia del dopoguerra, commentare tra sé e sé il suo volume I glossatori e la teoria della sovranità: nei suoi pomeriggi solitari, “una vasta estesione vuota”, da colmare attraverso i “due giochi” (la guerra e il calcio), scopre il gioco supremo, quello che gli consente di esercitare il “ruolo di totale neutralità”. Tale gioco è, ça va sans dire, la letteratura: “È una conquista graduale la possibilità di immergersi in un libro con la stessa intensità che si sperimenta nel gioco”. Attraverso la lettura pre-adolescenziale di Cime Tempestose scopre un ulteriore livello del gioco, la “passione”, che raffina nella “iniziazione erotica” di incisori e illustratori del secolo precedente, “attinta da quell’immensa riserva di sogni che era ancora l’Ottocento”.
La letteratura come eterna glossa al nulla (“Avanzando negli anni, si diventa, pur senza volerlo, lo scriba di se stessi”), è la base da cui fiorisce il mito, che è quindi gioco nella misura in cui è mistificazione: lungi dal rimare tutto su carta, ciò suscita l’eros. L’anima della letteratura, del mito e del gioco è dunque passionale, che nel mondo adelphico equivale a dire sacrificale. La solita hypnerotomachia, o anche “necromanzia” per gli pneumatici, evocata da Calasso stesso nel ritratto dello storico russo Rostovtzeff (amico di famiglia in quanto autore di punta della casa editrice del nonno Ernesto Codignola, La Nuova Italia), altro grande sciamano che possedeva “la qualità del necromante” (l’Autore cita un ricordo di Arnaldo Momigliano: “Rostovtzeff ci incantava e sorprendeva con il suo dono di richiamare in vita le cose antiche, dono che ci appariva inquietante”).
Questi sono in definitiva gli elementi di cui si compone la magia adelphica: gioco, mito, eros, sacrificio. E ad amalgama di questa “misticanza”, lo snobismo. Sì, quello snobismo che nella murti del dopoguerra italiano fu liberale, sfoggiato platealmente nel richiamo, seppur disilluso, al Partito d’Azione (“fatto soltanto di intellettuali”): “Erano i giusti senza ulteriore specificazioni, in uno stato chicamente puro, benevolmente rivolti verso sinistra”, modo d’essere del quale lo zio materno Tristano Codignola fu “l’incarnazione perfetta”.
Lo snobismo è il suggello di tutto, il tonico possente che chiude il libretto: esso è “ancora una volta a decidere” i destini della storia, segnatamente nel momento in cui lo storico dell’arte Ranuccio Bianchi Bandinelli, che doveva servire assieme al padre di Calasso come capro espiatorio per l’assassinio di Giovanni Gentile, venne salvato dal console tedesco in Italia, Gerhard Wolf, perché nel 1938 aveva accompagnato Hitler agli Uffizi. E tale fortunosa (dunque assolutamente necessaria) catena di eventi fu originata dal fatto che nel 1933 Bianchi Bandinelli fosse stato ospite di Guglielmo II, rifrancandolo sulle sue paranoie riguardo alle origine mitiche della civiltà germaniche, il cui “primitivo e unico centro di creazione e irradiazione” veniva identificato in Atlantide. Bianchi Bandinelli, che poi si convertì -in maniera piuttosto acritica, va detto- al comunismo togliattiano, assecondò quella “mentalità puerile e fantastica” sia nel Kaiser che nel Führer. Mi sembra che anche qui si possa concludere che le élite, come la letteratura e il mito, nascono dalla mistificazione.
Se in tutto questo c’è un barlume di coerenza, credo si possa solo identificare nella sprezzatura, che ne Il rosa Tiepolo Calasso definì “virtù suprema della civiltà italiana”, secondo la classica lezione del Cortegiano: “Usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi”. Probabilmente anche il genio è tale in virtù della sprezzatura: ma se il nasconder l’arte è parte della mistificazione, non vedo perché non si possa ridurre il tutto al nulla delle sue parti. E chiudere, quindi, con il paragone più sprezzante (in senso buono) che mi viene in mente: quello con The Longest Yard, Quella sporca ultima meta, film del 1974 di uno dei registi preferiti del de cuius, Robert Aldrich. L’ho rivisto l’altro pomeriggio su La7 dopo, credo, trent’anni dalla prima visione: l’insignificante commedia sportiva che poteva in effetti interessare un bambino di sei anni (un ex stella del football americano in galera deve organizzare una squadra dei detenuti per battere quella dei secondini) mi è apparsa sotto la luce del mito e del rito.
Il gioco come momento culmine dell’esistenza, potente tanto quanto la guerra, rituale che riesce a imporre le sue regole al di là dei rapporti di forza. Lo “spirito di squadra” tra detenuti che sorge, schimittianamente, dalla presenza di un nemico; l’allenatore, un ineccepibile Burt Reynolds, che diventa legibus solutus nel momento in cui accetta la proposta del direttore del carcere di mettere in scena il rito (la partita), come un Bianchi Bandinelli che gode del privilegio di aver camminato accanto ai miti (qui in senso barthesiano, suvvia); le “regole del gioco” che si impongono anche sull’inimicizia individuale e collettiva tra prigionieri e guardie. Eccetera eccetera. Ancora una volta, bisogna forse concludere che tutto l’affaire Calasso si cela nella sala di un cinemetto, durante una vasta estensione vuota da colmare che gli esseri umani chiamano “pomeriggio”…






Quasi quasi si avverte il fascino che codesto individuo esercita sull’autore della sinossi…