TikTok ha fatto tornare in auge l’espressione “maranza”, un modo di dire degli anni ’80 passato di moda in quello stesso decennio e sostituito da altri epiteti di origine ugualmente oscura (v. “truzzo”). Ormai lustri or sono con tale ingiuria soleva indicarsi, soprattutto nel milanese (ma sembra fosse in uso anche nel torinese), lo sbruffone, sguaiato nell’atteggiamento e nell’abbigliamento, che si poteva intuire da lontano un miglio avrebbe causato solo guai.
Non esiste tuttavia, almeno al momento, alcuna spiegazione riguardante l’origine del termine; per esempio, nel volume Scialla! di Giacomo Bendotti, acclamatissimo ma, oltre che ormai anacronistico (nonostante sia del 2011), piuttosto “giovanilista” e, in ultima analisi, cringe (voce che peraltro nel libro manca), l’Autore si limita a snocciolare questa definizione: «Tipo vistoso e volgare nei modi, prevalentemente di sesso maschile. Equivale a: coatto, truzzo, tamarro. In uso a Milano e Torino».
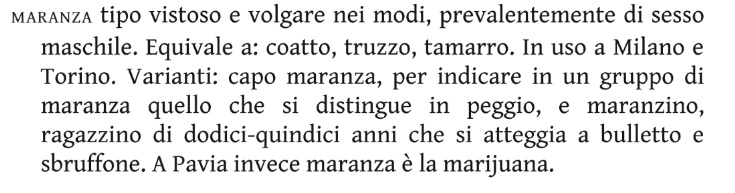
Prima di offrire la mia ipotesi sull’etimologia del termine, vorrei rivelare il “Segreto di Pulcinella” riguardo al suo recupero nello slang giovanile: la causa è da ricercare nella sua palese consonanza con “marocchino”, anche se ovviamente i giornalisti non si azzardano nemmeno a formulare un collegamento del genere, seppure siano costretti a parlare nei loro reportage parapiddini con frasi stucchevoli del tipo “il luogo comune ormai diffuso vuole che il maranza abbia anche la tendenza a delinquere e, che tra loro, ci siano molti stranieri. Nordafricani soprattutto” (fonte: “Wired”, che voleva togliere voti alla Meloni parlando di ‘ste stronzate).
In realtà, cliccando sull’hashtag #maranza su qualsiasi social (non solo TikTok), si può osservare come siano in primis i giovani di origine magrebina a utilizzarlo per mostrare le proprie rodomontate, talvolta anche in maniera autoironica (per quanto certi barbari sia orizzontali che verticali – bel casino, con le “seconde generazioni”! – siano capaci di autoironia). Ad ogni modo, che il modello sia quello lo si evince anche dal fatto che persino l’italiano che vuol fare il “maranzino” adotta non solo gli stessi codici culturali, ma addirittura linguistici, ripetendo espressioni gergali in lingue che ignora totalmente come l’arabo o il francese (akha, fils de pute, mitraillette, sacoche, cagoule…).
Però tutto ciò non si può dire, altrimenti si diventa rasisti. Allora torniamo agli anni ’80: per “sentito dire”, cioè da varie testimonianze alle quali tuttavia è impossibile risalire attraverso il web, so quasi per certezza che l’espressione maranza dovrebbe essere una crasi (ma forse sarebbe meglio chiamarlo un “neologismo sincratico”, anche se mi sembra comunque una definizione impropria, ma tant’è) delle parole mediterranean danza, nome con cui un tempo ci si riferiva al genere musicale oggi chiamato “italo-disco”. Beh, effettivamente non so un piffero di ’sta roba dunque parlo solo per sentito dire.
Per non chiudere in tristezza, sia per la mia insipienza, sia per il cringe, se non il trash (la Crusca conferma che non sono la stessa cosa) che l’argomento in sé ispira, allungo la solfa con qualche altra etimologia fantastica: per esempio, “gas”, neologismo creato dal chimico (=mistico & alchimista) Jean Baptiste van Helmont come derivazione dal greco antico chaos e in assonanza con geest (“spirito” in fiammingo) e blasen (“soffiare” in tedesco); minta, termine introdotto nella lingua ungherese dal gesuita János Sajnovics nel XVIII secolo durante il “rinnovamento” (nyelvújítás), una parola di origine lappone (mintâ) derivata a sua volta dal nordico antico (mynt) che l’ha intuibilmente adottata dal latino (“moneta”), la quale però in magiaro ha assunto il significato di “modello” perché un altro gesuita, Ferenc Faludi (1704-1779) la prese da un lessico lappone dove, per un errore di stampa, la giusta traduzione della parola minstar (“modello”, appunto, dall’italiano mostrare attraverso il tedesco Muster) era riportata una linea più in basso accanto a mynta!
Mi piace poi ricordare l’espressione malese jantina, “parola macedonia” tra jantan (“maschio”) e betina (“femmina”) che indica il sesso biologico (cioè il genere, a cui è equivalente per natura e cultura), la quale viene attribuita dal Wiktionary al linguista indonesiano Harimurti Kridalaksana ma che in realtà il Bausani attesta già nella pubblicistica degli anni ’70 del secolo scorso e addirittura fa risalire alla pratica degli “indovinelli” (cangkriman kerasan) in auge a Giava, dalla quale deriverebbe il nome dell’isola stessa, come ngudja-hawa (“prono alle passioni”) o sedja-rowa (“dedito alle stravaganze”), anche se è attestato che il nome risalirebbe al sanscrito yava-dvīpa, “isola dell’orzo”.
Infine, segnalo l’utilizzo della volgarissima espressione inglese arse (“culo”) che nel pidgin melanesiano è diventato sinonimo di “base, fondamento, ragione”, tanto da essere usato persino dai missionari: ancora il Bausani riporta l’esempio di un catechismo in cui Dio è definito arse belong all-[to]gether something, “la base di tutte le cose”, invitando a immaginarne l’origine nell’utilizzo di “qualche rozzo ma inventivo marinaio per spiegare all’indigeno parole come ‘base’, ‘fondo'”.








Interessante!
Io in due dizionari etimologici ho trovato questa etimologia di ‘minta’ senza il gustoso aneddoto del dizionario stampato more mentulae canis, e che attribuisce il ‘danno’ al solo Sajnovics (ne traduco una delle due, tanto si equivalgono):
… A ’pénzérme’ jelentésű lapp mintâ főnév alapján jött létre. Sajnovics János a norvégból származó lapp szót tévesen ’minta’ jelentésűnek vélte, és ‘mint a’ hasonlító szószerkezetünkkel hozta összefüggésbe…
… [La parola] si è formata sulla base del sostantivo lappone mintâ, che significa ‘moneta’. János Sajnovics ritenne erroneamente che la parola lappone di origine norvegese significasse ‘minta’ (esempio), e la mise in correlazione con il nostro (cioè ungherese) costrutto ‘mint a’ (come il)…
Approfitto per fare a tutti gli auguri di una Santa Pasqua!
PS: non ho scritto in oenmarkusko, stavolta, tanto ci pensa l’ungherese ad essere… incomprensibile di suo 😀 !
Auguri a tutti anche da parte mia!
Mi fai venire il dubbio che l’aneddoto sia un’invenzione di Otto Jespersen (la mia fonte), che in effetti offre come indicazione generica Die ungarische Sprache di Zsigmond Simonyi e comunque attribuisce anche al Faludi (e non allo Sajnovics) la correlazione con “mint a”. Probabilmente è stato il Faludi a fare tutto e il suo “successore” gesuita ha ratificato lo pseudo-prestito…
Non so adesso, ma negli anni’70-’80, presso l’Orientale di Napoli esisteva il corso di FONETICA SPERIMENTALE. Ovvero ipotesi sulle lingue del futuro .
PARLA 112 LINGUE, HA SOLO LA LICENZA ELEMENTARE, 94 ANNI E VIVE IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, COLTIVANDO LA TERRA ED ALLEVANDO ANIMALI.
Riccardo Bertani, dopo le elementari ha studiato da autodidatta idiomi dimenticati: dal mongolo alle lingue siberiane, pubblicando oltre 1000 volumi.
Ribelle fino in fondo, il contadino poliglotta si prepara col sorriso ad andare “verso l’infinito”. Bertani, in 70 anni di studi e traduzioni ha scritto e realizzato più di 1000 volumi, arrivando a conoscere da autodidatta oltre 100 lingue.
La sua storia, quella del contadino poliglotta, o del glottologo dell’ “7estremo mattino”, è davvero particolare. Nato nel 1930 in una famiglia contadina, con il padre ex sindaco iscritto al partito comunista, lasciò la scuola appena dopo le elementari. “Era castrante, sono fuggito. Mi interessava altro. Devo dire che solo una maestra mi capì”. Allergico alla matematica, iniziò a lavorare nei campi “ma ero e sono un contadino sbagliato, non certo un contadino modello”.
Perché più che le biolche da coltivare o gli animali da allevare “io avevo sempre in testa i libri – racconta – quelli che cominciavo a capire”. Nell’abitazione dei genitori, in quegli anni dell’Italia fascista, c’erano per lo più solo tomi russi. Bertani inizia giovanissimo a sfogliare Tolstoj, a leggerli in italiano, poi compra una grammatica russa e approfondisce: “Ho iniziato a tradurre. Intorno ai 18 anni non facevo altro. Ero attratto dall’Oriente, la Russia, l’Ucraina”. Era attratto dall’alba. “Da anni, mi sveglio alle due del mattino e mi preparo all’arrivo del sole. A quell’ora il mio cervello non sta fermo, ho la mente limpidissima, così comincio a studiare”. È l’amore per l’estremo mattino.
Crescendo tra la biblioteca comunale e amici che lo sommergono di volumi lui si immerge completamente nelle lingue. È attirato come una calamita dalle culture dei popoli siberiani, russi, mongoli. Vuole sapere come vivevano, come quei dialetti si spostavano. Comincia a scrivere tutto a mano sulle agende delle banche, annota i significati delle parole, la pronuncia. “Mi interessa il folklore, le tradizioni, le leggende. Lo sa che i siberiani hanno un’altra preparazione al concetto della morte? Non è un concetto così distinto dalla vita”.
In 70 anni di lavoro (la sua bibliografia va dal 1956 ad oggi) esplora lingue sconosciute e dimenticate, rendendole comprensibili per gli italiani. Un patrimonio che ha deciso di lasciare a tutti noi: la sua casa è diventata un Fondo e lui – che nella vita si scriveva lunghe lettere con Claude Lévi-Strauss per conversare sulla mitologia germanica – invita gli appassionati di lingue scomparse ad andarlo a trovare, a leggere quel che ha scritto.
Sospinto dal vento freddo che lo porta nella “tundra e la taiga” ha imparato lo Jacuti, Jugakiry, Burlati, il basco, le lingue etrusche e longobarde, il mongolo, l’eschimese e tantissime altre creando dizionari veri e propri: “Ecco, questo è il Rutulo-Italiano, quest’altro il Prusso-Italiano” spiega mentre tira fuori ogni sorta di carpetta con le immagini dei mondiali anni Novanta.
È un uomo lucido, visionario, estremamente appassionato. “Non so l’inglese, né il tedesco – racconta seduto alla sua scrivania – non ho la patente e a parte per i documentari di animali e scienza, non guardo la televisione. Internet? Ma va là”.
È difficile parlare di web o connessioni a un uomo che scriveva sulla carta del mangime per le vacche e ha provato a battere a macchina “ma riuscivo solo con un dito”, un uomo che viaggia tantissimo ma solo con la mente. Gli chiedo perché non è mai uscito dall’Italia, risponde sincero: “Ho paura di rimanere deluso. Mi sono fatto un’idea della Russia dai libri. Mi hanno invitato a Mosca, in Bulgaria, più volte. Ma io preferisco restare qui: per me temo sarebbe come vedere la Grecia oggi dopo aver letto l’Eneide”.
Osserva e traduce come le correnti migratorie mescolano e spostano le lingue. Scrive libri che vanno da Verso l’estremo mattino – Antologia epica dei popoli siberiani […]Nel corso della sua lunga storia è stato invitato a parlare in diverse Università Italiane, ha discusso di lingue con Franco Battiato, è stato insignito di premi di vario genere appesi fra la polvere sul muro dietro alla sua poltrona.
Crede che ormai tutte quelle lingue antiche “vadano a estinguersi per sempre”, e che il dialetto purtroppo “non ha più senso insegnarlo a scuola. Per parlare e capire il dialetto bisogna pensare in dialetto. E ormai i bambini non lo fanno più”.
Riccardo è stanco e deve fare una pausa. L’amico Luigi Rozzi, con cui condivide la passione per le lingue, mostra un gazebo all’aperto nel cortile. Una volta lì intorno c’erano oche e capre, ora soltanto galline. Il tempo comincia a farsi sentire. Ma Bertani, come fece quando lasciò la scuola, continua a sentirsi “un ribelle, in tante cose”