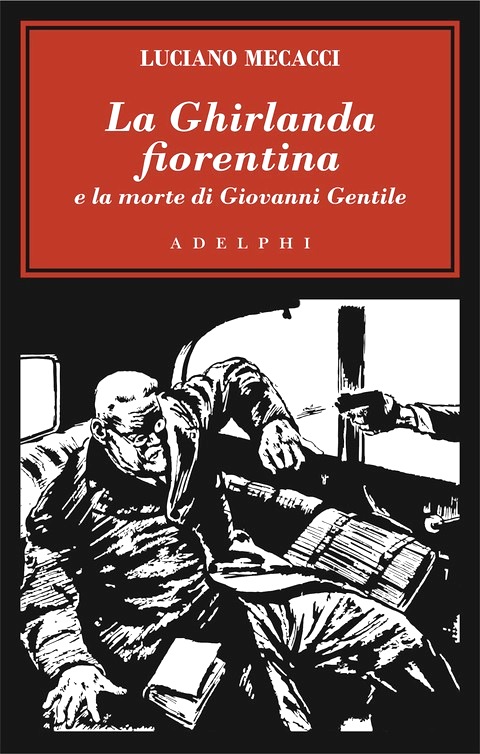Nel dicembre 2013 Roberto Calasso annunciava in un’intervista la pubblicazione di un testo sull’assassinio di Giovanni Gentile, dal quale sarebbero emerse «verità sconvolgenti». Ora che La ghirlanda fiorentina è arrivato nelle librerie, scopriamo che di sconvolgente c’è soprattutto la capacità di Adelphi di imprimere il proprio marchio anche sulla più imparziale ricerca storica. A rendere questo libro un gioiello non sono infatti né l’argomento in sé, né il monumentale apparato di note, la sterminata bibliografia o i documenti inediti scoperti dall’Autore, quanto lo “spirito” che anima la narrazione.
Lo scenario della ricerca di Luciano Mecacci (già autore de Il caso Marilyn M.) è, secondo il risvolto di copertina, «la Firenze cupa e claustrofobica occupata dai tedeschi», nei giorni di quell’aprile 1944 in cui Giovanni Gentile venne freddato sulla strada del ritorno a casa.
La “cupezza” e la “claustrofobia” sono elementi essenziali di una Storia che diventa luogo eletto dell’inganno e della dissimulazione, dove all’approssimarsi della verità si accompagna un insostenibile senso di vertigine.
Prima di affrontare la “forma” della narrazione, tuttavia, è necessario partire dai contenuti: nella sua ottima recensione (Agguato a Giovanni Gentile. Riemerge la pista britannica, “Corriere della Sera”, 1 aprile 2014), Paolo Mieli concentra l’attenzione sulle ipotesi finali prospettate da Mecacci, ponendo in secondo piano il minuzioso lavoro di scomposizione e ricostruzione dei rami intrecciati di questa ghirlanda insanguinata, grazie al quale l’Autore ha aperto «squarci in zone d’ombra dove la luce non era mai penetrata, senza avere la pretesa di dire una parola definitiva».
In realtà l’idea che dietro all’uccisione del filosofo potesse esserci una “mente inglese” non è mai stata scartata dagli storici, tanto è vero che ciclicamente torna alla ribalta: il primo a formularla, su suggerimento di Curzio Malaparte, è Benedetto Gentile, figlio del filosofo, nel 1951; pochi anni dopo, nel 1956, Luigi Villari accusa il sistema radio impiantato dagli Alleati sul territorio nazionale di aver “passato” l’ordine di esecuzione; nel 1985 Luciano Canfora con La sentenza si impegna a dare un sostegno storico più robusto alla tesi; anche Renzo De Felice, in una delle sue ultime opere, accenna cautamente al ruolo dei servizi segreti britannici: «Erano tempi in cui bastava una “parolina” ben detta…» (Rosso e Nero, 1995).
Quello che c’è di nuovo nel libro di Mecacci è la ricostruzione suggestiva e al tempo stesso angosciante del clima accademico e culturale fiorentino dell’epoca, nel quale l’Autore si è orientato seguendo, come abbiamo detto, i rami della “ghirlanda”, ovvero un quaderno d’appunti (intitolato proprio Ghirlanda fiorentina) in cui l’italianista scozzese John Purves nel 1938 annotò, per conto dei servizi inglesi, i nomi «degli uomini […] di cultura con cui, nell’eventualità di un conflitto che ormai si profilava all’orizzonte, sarebbe potuto entrare in contatto per proporre una collaborazione a livello di intelligence».
Dall’elenco emergono personalità appartenenti al milieu che Elena Croce descriverà come “snobismo liberale”, una sorta di impero invisibile che anima le ville e le scuole della Toscana profonda. Senza una adeguata preparazione culturale, ad avventurarsi in questi cenacoli si rischia come minimo il martirio intellettuale. Neppure Mecacci riesce a lungo a sostare nelle «zone d’ombra» (tra le pagine più stranianti, quelle dedicate ad “Aris” e alla sua enigmatica identità, pp. 192-198) ed è più volte costretto a tornare su suoi passi, alla luce dell’erudizione e soprattutto della bibliofilia (magistrale il capitolo dedicato alla figura di Mario Manlio Rossi, gli “amici” del quale Gentile temeva più di tutti).
Alla fine è la Storia stessa a uscirne sconfitta: forse essa non è altro che a tale told by an idiot, o ancora meglio a nightmare from which I am trying to awake. A trionfare sono la mistificazione e l’inganno, non soltanto a livello particolare: è la roccaforte della Firenze albionica, quella moltitudine opaca di agenti segreti, nobiltà iniziatica e docenti di italianistica, a configurarsi come l’ostacolo più arduo alla scoperta della verità (non è un mistero –o forse lo è!– che Firenze sia una delle “città sante” dell’international Anglophile network del quale parlava lo storico statunitense Carroll Quigley).
Da questo punto di vista, fanno un certo effetto le metafore utilizzate da Mecacci: a parte quella “vegetale” della Ghirlanda («un insieme di elementi diversi – fiori misti, foglie – fra loro intrecciati»), nelle pagine finali ne emerge un’altra, definitiva: quella dei cerchi nell’acqua.
«Si parte da un cerchio interno, ristretto a coloro che presero inizialmente la decisione, da cui si irradia il movimento dei cerchi più periferici, fino ad arrivare all’ultimo cerchio, quello dei gappisti, che infine produce l’onda distruttiva» (p. 344).
Che la storia sia veramente un incubo dal quale non ci si risveglia? Del resto anche il “mestiere” dello storico comporta una buona dose di turbamenti, ossessioni e inquietudini. Se non ricordo male, fu Valéry a descrivere lo studio del passato come una sorta di “chiromanzia a ritroso”. Nel caso di Gentile, potremmo dire con Mieli che «i colpi non furono esplosi per il suo passato, ma per il futuro», ovvero per soffocare sul nascere ogni tentativo di riappacificazione nazionale e far scoppiare la guerra civile in tutta la sua brutalità.
Mecacci, consapevole di tutto questo, nelle ultime righe del suo libro lancia un’accusa nei confronti di un intero mondo culturale, con la quale riesce nuovamente a nobilitare (anche nel mero senso “moralistico”) il ruolo dello studioso:
«Una cosa però è certa – la morte di Gentile rinforzò un abito, non infrequente, degli intellettuali italiani: obbedire ai diktat del proprio partito, autoassolversi, soddisfarsi delle vulgate, nel migliore dei casi tacere» (p. 346).
Per quanto la verità sia dolorosa e disarmante, resiste l’aspirazione all’onestà intellettuale: la storia non è quindi né giustiziera né giustificatrice ma, fuori da ogni retorica, maestra di vita, portatrice di luce in un mondo «cupo e claustrofobico» affinché l’inganno e la mistificazione non pronuncino l’ultima sentenza.
Postilla
Quando Togliatti censurò Lenin
Nella sua straordinaria inchiesta, Luciano Mecacci in un nota (a p. 429) rispolvera un aneddoto poco noto riguardante Palmiro Togliatti: quando il leader comunista curò la traduzione dal russo della voce dedicata a Marx redatta niente di meno da Lenin per lo storico dizionario enciclopedico Granat (Гранат), egli “omise” la bibliografia per il semplice motivo che in essa il leader bolscevico mostrava un certo apprezzamento per un volume del “filosofo del fascismo”. Così infatti scriveva:
«È degno di attenzione il libro dell’idealista Giovanni Gentile, La filosofia di Marx (Pisa, 1899): l’autore rileva alcuni aspetti importanti della dialettica materialistica di Marx che di solito sfuggono all’attenzione dei kantiani, dei positivisti, ecc.»
Lo stesso Gentile mise in risalto questa “onorificenza” nell’introduzione alla nuova edizione de La filosofia di Marx del 1937, che venne ripristinata solo alcuni anni dopo, nell’edizione delle Opere Complete per Editori Runiti curata da Rossana Platone nel 1966.