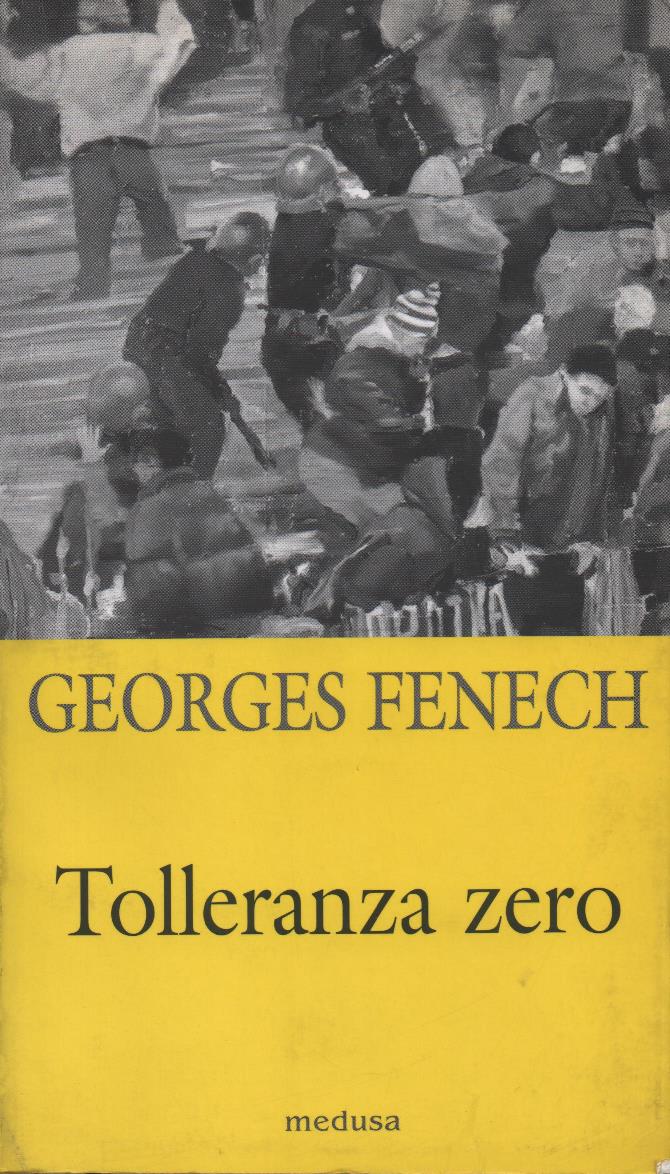Traduciamo un articolo di “Le Monde” sull’architettura delle periferie parigine, risalente ai tempi delle sollevazioni nelle banlieue, con il quale in realtà concordiamo solo in parte, nel senso che non escludiamo per partito preso la natura “criminogena” delle condizioni in cui si è costretti a vivere, ma non per questo crediamo che la soluzione sia rifiutarsi di punire i delinquenti a seconda dei quartieri in cui vivono (tale atteggiamento per certi aspetti non fa che acuire la piaga).
L’utopie manquée des cités-dortoirs
(Grégoire Allix,, “Le Monde”, 6 dicembre 2005)
Colpevoli, complici, innocenti? Gli architetti sono spesso chiamati in causa nel processo ai grandi complessi urbani, rilanciato dalle violenze urbane di queste ultime settimane.
Il capo d’imputazione: aver creato una cornice di vita oggi rigettata e degradata, senza che si riesca ancora a capire se il corpo del reato stia nel materiale (il “cemento criminogeno”) o nella forma (“i palazzi e i grattacieli disumani”).
Il loro breviario: la Carta di Atene, elaborata nel 1933 al Congresso internazionale di architettura moderna e pubblicata nel 1943 da Le Corbusier. I loro grandi principi: costruire, lontano dai centri tradizionali, delle città radiose fatte di “macchine per abitare” collocate in palazzi e grattacieli distanziati e soleggiati, circondati dalla natura, collegati con autostrade sia a quartieri dedicati al lavoro che ad altri pensati per il tempo libero. Questo modello utopico sicuramente costituisce il primo atto d’accusa, per la negazione di una città modellata sulle vie e piazze in grado di collegare abitazioni, uffici e negozi. «Invece di concepire città portatrici di una continuità, i grandi agglomerati creano un evento ideale dove lo spazio è generato dall’ampliamento di cellule», denuncia da tempo l’architetto Roland Castro, animatore del gruppo “Banlieue 89” durante gli anni ’80. «Gli edifici non hanno alcuna relazione con le strade, la città vive per sé stessa, lontano da tutto. La simbiosi si ottiene solamente se i luoghi donano alla gente la voglia di vivere e la possibilità di arrivarci».
“Grand prix de Rome”, rappresentante di spicco dell’architettura francese del dopoguerra, Jean Dubuisson è autore di numerosi complessi abitativi. «Non dico che tutto quello che abbiamo fatto sia giusto» giudica oggi il novantunenne. «Ma non è la forma dei palazzi o dei grattacieli che li rendono inabitabili. Il problema è l’urbanistica. Abbiamo sbagliato a costruire lontano dai centri urbani. La gente si è sentita esclusa». Soprattutto i mezzi di trasporto sono spesso in ritardo e non riescono collegare questi quartieri tra di loro o al centro.«Sono addolorato per quel che sta accadendo», confessa Jean Dubuisson. «La Carta d’Atene contiene principi molto generali. Non dovevano essere applicati in maniera così sommaria. Una città è fatta di quartieri la cui personalità attrae la gente. Il problema è che questi grandi agglomerati concentrano persone che non hanno scelto di vivere lì».
La specializzazione delle funzioni, teorizzata dal movimento moderno, ha aggravato il malessere nel creare città-dormitorio, carenti di negozi e attività.
«La “zonizzazione” [zoning] è una stupidaggine, ci vuole il lavoro nelle città. La vera mixité è quella delle funzioni, che favorisce la mescolanza sociale», sostiene Paul Chemetov. Al vizio di forma si aggiunge un elemento in più: la scarsa qualità architettonica e urbana di queste città, che assomigliano più a delle gabbie per conigli in mezzo ai campi di erba medica che alle città radiose descritte da Le Corbusier.
«I grandi complessi sono stati, per molti architetti, delle operazioni puramente tecniche, che hanno permesso loro di vivere da nababbi», accusa Chemetov […]. «Gli architetti dei grandi agglomerati non hanno mai pensato di viverci loro stessi. Le grandi agenzie non prendevano commissioni per meno di mille unità. Stabilivano tre o quattro moduli e li impilavano come Lego per realizzare città intere, senza interrogarsi sulla commissione né sul contesto locale».
All’ombra dei grandi agglomerati, qualche architetto difende nelle banlieue programmi su scala più ridotta, dalle forme più varie, articolati in quartieri. Tra questi, Renèe Gailhoustet che ha collaborato, tra gli altri, col movimento di Jean Renaudie. «Noi rifiutiamo la sudditanza degli architetti alle pretese degli imprenditori» afferma. «È sospetto che qualcuno possa concepire migliaia di alloggi con tre modelli di cellule. Una miriade di architetti importanti si è gettata sugli alloggi sociali per sfruttare quel mercato, sono diventati degli affaristi. Ma è stato solo stoccaggio, non architettura. Non a caso quelli che hanno avuto la possibilità di trasferirsi in zone residenziali o veri centri città, lo hanno fatto alla prima occasione».
Sotto i colpi della crisi economica, le classi medie, che hanno scoperto, entusiaste, i confort moderni tra i grandi complessi, hanno lasciato il posto a una popolazione precaria e impoverita […]. Senza manutenzione gli edifici si deteriorano, gli spazi verdi appassiscono. I comuni si rifiutano, anche dopo la décentralisation, di impegnarsi in questi quartieri nati da una politica volontaristica dello Stato. Le infrastrutture collettive promesse vengono dimenticate, i servizi pubblici scarseggiano. Il risultato, esplosivo, è noto.
«Lo scenario non ha creato la miseria, ma la miseria ha trovato il suo scenario ideale» ricorda Roland Castro. In difesa di queste città, Paul Chemetov e Jean Dubuisson ricordano che la qualità degli edifici, la conservazione degli equilibri sociali e le infrastrutture hanno permesso ad alcuni grandi agglomerati di sopravvivere: i palazzi di Dubuisson a Chambéry e Montparnasse, di Pouillon a Meudon, di Lods a Marly-Les-Grandes-Terres, di Henri-Labourdette a Sarcelles… «C’è una città a Ginevra per i funzionari internazionali, che rappresenta una stretta applicazione dei principi della Carta d’Atene e funziona perfettamente», sottolinea Paul Chemetov.
«Negli Stati Uniti i disordini hanno avuto luogo nei quartieri a urbanizzazione tradizionale, come Harlem e New York», aggiunge Christian de Portzamparc, autore a Parigi dei grattacieli delle Hautes-Formes (13e arrondissement) e del restauro dei palazzi della rue Nationale (13e) […]. «Se le città francesi fossero costituite da piccole case e piccoli immobili, la cosa non avrebbe importanza. La forma dell’urbanizzazione del dopoguerra comunica certamente un sentimento di sconforto. Ma quel che è in gioco in tal caso è in primo luogo la povertà e, in campo urbano, la zonizzazione funzionale, l’assenza di coesione sociale che ha favorito la costituzione di spazi di segregazione».
Relativizzando la responsabilità degli architetti, il vincitore del Gran premio nazionale di urbanistica 2004 ritiene che «all’epoca era facile lasciarsi accecare dall’idea di progresso. E se la zonizzazione si è rivelata una enorme sciocchezza, non è perché è stata applicata come un’utopia architettonica, ma perché questa separazione di funzioni era perfettamente strutturale agli interessi economici e tecnici dell’epoca moderna».
Bernard Reichen va più lontano. Per questo architetto, nonostante gli errori commessi negli anni ’60, i grandi agglomerati prefigurano ancora la città del futuro. «La forma urbana non è di per sé stessa patologica. I grandi agglomerati sono stati la base di una città fuori dalle mura, mentre nei secoli le città sono state sempre costruite integrando progressivamente le periferie. Questa rottura non è stata un errore. Essa segna il passaggio dalla città antica, radioconcentrica, a una città territoriale, che rappresenta la realtà di oggigiorno. In questo senso molti degli articoli della Carta di Atene sono validi». Una posizione marginale o anacronistica? Bernard Reichen ha ricevuto lunedì 28 novembre il Grand Prix national d’urbanisme 2005…