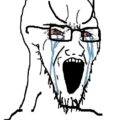Alessia Piperno è quella ragazza (o forse bambina per gli standard odierni, essendo una trentenne occidentale) arrestata circa un mese fa in Iran per un problema burocratico (un visto scaduto, almeno a stare alle testimonianze della diplomazia italiana), trasformato però dai media in questione politico-umanitaria (opposizione al velo islamico, sostegno alle rivolte).
Durante la sua prigionia non mi ero permesso di esprimere particolari considerazioni sulla persona della malcapitata, risentendomi tuttavia del fatto che gli italiani venissero tutti descritti come dei trogloditi maschilisti favorevoli al regime degli Ayatollah, mentre invece era esattamente il contrario. Ora che però la vicenda si è conclusa per il meglio, vorrei togliermi qualche sassolino dalla scarpa.
In primis, partiamo almeno da un dato positivo: il ritorno della Piperno non ha avuto le stesse caratteristiche oscene e demenziali di quello (per chi se la ricorda) di Silvia “Aisha” Romano, altra ragazza o bambina (26 anni) rapita in Kenya dall’organizzazione terroristica somala Al Shabab e poi tornata in Italia in piena pandemia (maggio 2020) dopo adeguato compenso ai terroristi, con il coro di khmer giallo-rossi a elogiare sia gli assembramenti dei giornalisti sotto casa sua che la sua conversione all’Islam (spacciata come “scelta libera di una donna indipendente” dalle Selvatiche Tarzanelli di turno).
Questa volta la Piperno è stata ricevuta sobriamente dalla premier nazifascista nemica delle donne Giorgia Meloni ed è tornata da mamma e papà senza eccessivo clamore mediatico. Ora, prima di archiviare per sempre la vicenda, mi permetto di rimandare alle considerazioni espresse circa un mese fa aggiungendo solo un ricordo di Marthe Lucie Lahovary (1886-1973), conosciuta anche con il titolo di Princesse Bibesco (conseguito col suo matrimonio, a sedici anni, col principe Georges Bibesco).

Espressione di quella élite francofila bucarestina che avrebbe contributo in maniera cruciale alla modernizzazione della Romania, la Bibesco crebbe a Parigi e non imparò la sua lingua nazionale che a undici anni. Nel 1905 intraprese un lungo viaggio in Persia a seguito del marito, incaricato dalla corte romena di una missione presso lo Scià. Gli appunti di quel viaggio si trasformarono ne Les Huit Paradis, uno dei libri di viaggio più letti dell’epoca (tradotto in italiano solo nel 1994 da Sellerio), elogiato da Marcel Proust (“Quelle pagine dipinte in modo così delizioso da sembrare delle turcherie del Seicento”) e da Guillaume Apollinaire (“Che gioia incontrare un’anima europea in un’opera sulla Persia”).
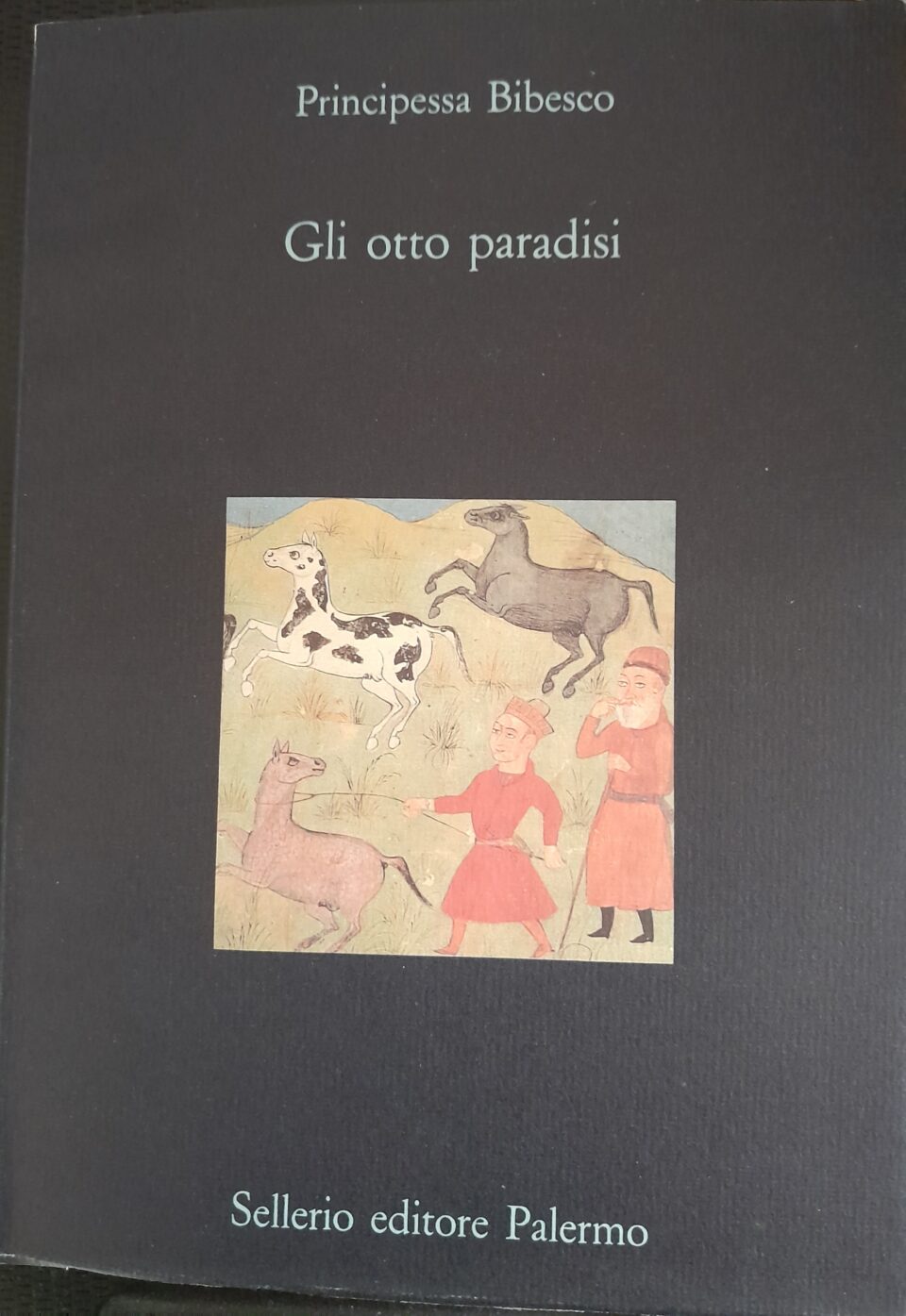
Uno dei suoi compagni di viaggio, il giornalista Claude Anet, descrisse la Principessa come una giovane donna abituata alle comodità e al lusso che però si adattò immediatamente “alle notti senza sonno, alla scarsità di cibo, agli alloggi sudici e infestati da parassiti, al freddo dell’alba, al vento gelido delle montagne e al calore che sale dal deserto così forte che si resta intorpiditi e si vorrebbe morire”. Eppure non una briciola di sofferenza si trova nelle pagine del suo capolavoro: la Principessa Bibesco ci teneva a mantenere la sua immagine alata, incastonata dal suo biografio Ghislain de Diesbach con queste parole: “Attraversava l’Europa come una preziosa incarnazione della sua epoca, parata dei tre doni essenziali, talento, eleganza e bellezza”.
Lo spirito con cui Marthe Lahovary affrontò lo “Stato Sublime di Persia” (denominazione ufficiale sotto la dinastia Qajar) era intriso di letterario: nelle sue memorie Firdusi si unisce a Racine, Sa’di a Verlaine, i salotti parigini proustiani alle scuole sufi di Esfahan. Non per questo mancano riflessioni concrete sugli usi e costumi di quei popoli; come ricordano le curatrici dell’edizione italiana (Riccarda Marinelli e Rosetta Signorini), per esempio sull’attualissima questione della condizione della donna in Oriente, la Bibesco riuscì a esprimere giudizi altrettanto attuali:
«Pur riconoscendo gli aspetti più oppressivi dello stato di subordinazione [delle donne], è anche capace di intuire certe vantaggiose libertà che lo stesso costume consente – il velo, ad esempio, come maschera alle devastazioni del tempo e uniforme capace di annullare l’ingiusta ripartizione della bellezza – e di cogliere nella legge coranica norme disposte a protezione della donna per molti versi più avanzate di quanto non lo fossero nella contemporanea legislazione europea».
L’ultimo “paradiso” (inteso in senso etimologico, come dilettevoli giardini degli antichi re persiani) visitato dalla Principessa fu la Costantinopoli ottomana, città alla quale era legata attraverso la madre, discendente della famiglia fanariota dei Mavrocordato, e che considerava la sua “fonte di giovinezza”. Con uno struggente epitaffio dedicata alla Città d’Oro si concludono infatti le sue memorie: Ne vous attachez pas à cette terre si belle, car le jour passera sur vous, et le Temps compte chacune de vos pulsations (“Non vi legate a questa terra tanto bella, perché il giorno passerà su di voi. E il Tempo conta ognuna delle vostre pulsazioni”).
Queste invece le parole con cui Alessia Piperno ha rischiato di passare alla storia: “Da quando sono in Iran, NON vado più in diarrea. […] Dalle lenticchie del Pakistan, sono passata a mangiare tutti i giorni le melanzane. Ormai è un mese. Non le sopporto più. Ho scoperto che non ordinerò più una pizza in Iran. Sto cazzo di ketchup”.
Non ingannatevi: non sto facendo una comparazione tra un’aristocratica del XX secolo e una plebea del XXI. Per me la Piperno è tutt’altro che plebea, come ho già scritto, anzi fa parte di una nuova classe di privilegiati, in tal caso di chi può permettersi di vivere e mantenersi come travel blogger. Per comportarsi come membro di un élite tuttavia si dovrebbe avere qualche qualità in più rispetto al popolaccio: è incredibile però come per il mainstream in questi casi valgano solo le qualifiche di “donna bianca occidentale”, che in altri campi (i concorsi di bellezza, gli stupri nelle periferie, l’educazione sessuale nella scuola primaria) sono viste come oppressive, degradanti e naturaliter retrive.