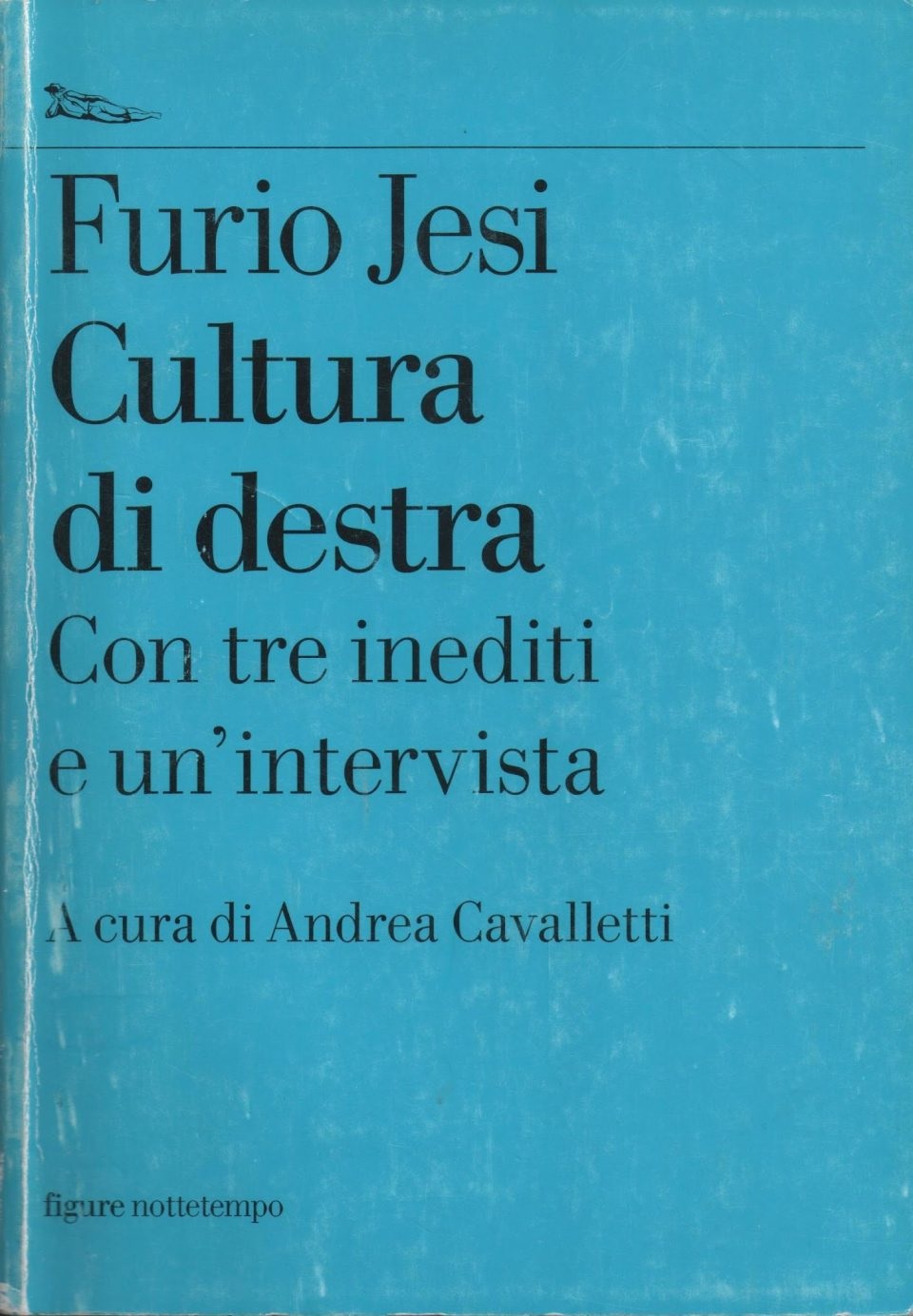
La brandizzazione del nome di Furio Jesi, che ha dato il via a iniziative editoriali tanto iperboliche quanto discutibili, rende necessario domandarsi se al di là del feticismo un po’ hipster abbia ancora senso rileggerne le opere. Dalla sua resiste l’alibi di una morte prematura che permette di apprezzarne soprattutto le potenzialità, nello stesso modo in cui, per esempio, si legge ancora Adorno solo per trovare tra le pagine di Minima moralia l’abbozzo di una condanna alla contestazione studentesca (del resto è così che Leonardo Ceppa introduce l’edizione del 1994: «Alcuni aforismi potrebbero presentarsi oggi come i primi elementi di una “critica della personalità antiautoritaria” che la crisi del post-Sessantotto ha finito per rendere opportuna»)[1].
È con tale disposizione mentale e spirituale che andrebbe affrontato Cultura di destra, tragicomico affresco della reazione da Eliade a Montezemolo (sic), evitando di soffocare nel tanfo di modernariato anni ’70, ovvero auspicando che uno Jesi redivivo dix ans plus tard (1989) avrebbe trovato modo di scrivere anche un Cultura di sinistra invece che, per esempio, diventare un tristissimo collaboratore di “MicroMega” o roba del genere.
In fondo Cultura di sinistra (inteso come volume potenziale) è contenuto seminalmente in tutta l’opera del Nostro: come Jesi sostiene proprio in Cultura di destra (ristampato dalla romana Nottetempo nel 2011), «la maggior parte del patrimonio culturale, anche di chi oggi non vuole affatto essere di destra, è residuo culturale di destra», e per questo motivo «vi sono buone ragioni di allarmarsi […] quando in numerosi discorsi celebrativi proprio della Resistenza ricompare il linguaggio delle idee senza parole», cioè appunto la lingua della destra (p. 26). Lo stesso motivo, abbandonata definitivamente la dicotomia mito genuino/tecnicizzato, è presente in Letteratura e mito (Einaudi, Torino, 2002): «Anche la dottrina politica più progressista si serve di uno strumento intrinsecamente reazionario quando fa ricorso al mito» (p. 42). E ancora lo ritroviamo nell’introduzione a un’antologia sul tema della festa del 1977 (“Conoscibilità della festa”, ora ne Il tempo della festa, Nottetempo, Roma, 2013):
«Il nostro atteggiamento non può […] accogliere come certa l’ipotesi che in una società diversa da quella borghese, in una società nata da una rivoluzione socialista, il grado di collettività raggiunto dalle esperienze dell’esistenza e della cultura sia direttamente proporzionale a una recuperata qualità festiva» (pp. 107-108).
Tuttavia se Jesi avesse seguito questa linea nell’affrontare la “cultura di sinistra”, probabilmente non avrebbe fatto altro che portare al parossismo la sua brutta abitudine di far passare chiunque per un nazi: non soltanto Eliade (che in una pagina del Journal lo scrive proprio: “Jesi vuol farmi passare per nazista!”[2]), non soltanto l’esterrefatto Kerényi che si ritrovò una bella “M” (di “mascheratura”) sulla spalla (e rispose all’impertinenza di Jesi dandogli dell’italo-comunista), ma persino quei poveri spartachisti accusati di alimentare, con la mistica del sacrificio e del martirio, la mitologia della “religione della morte” (cfr. Spartakus, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, p. 53) e, soprattutto, il grande Cesare Pavese, che Jesi maltratta in maniera intellettualmente scorrettissima. Fa quasi senso trovare indirettamente accostate, in Letteratura e mito, l’“espiazione” dei nazisti a quella dello scrittore piemontese:
«Il “passato” per i nazisti […] coincise con l’inabissarsi nelle immagini deformi del passato offerte dalla tecnicizzazione del mito. Privo di ogni valore di collettività, quel linguaggio attingeva ad immagini mitiche deformi in cui si erano proiettate le malattie e le colpe dei criminali, ed in cui ciascuno si abbandonava ciecamente al flusso dell’inconscio, ritrovando in quell’esoterismo mostruoso una conferma ed un precedente mitico delle proprie malattia e delle proprie colpe» (p. 40).
Al “suo” Pavese, Jesi fa dire esattamente il contrario di quanto sostenne il Pavese reale, che non voleva certo “vivere il mito” suicidandosi, semmai “portarlo a chiarezza” attraverso il mito genuino del socialismo. È un fraintendimento grave, che Jesi non riesce a correggere neppure nel 1975, riprendendo il tema per una lezione universitaria (“Cesare Pavese e il mito: Dix ans plus tard”, ora ne Il tempo della festa), pur riconoscendo tra le righe l’“onestà” del suicidio di Pavese come ultima speranza per un borghese (sempre meglio che nazista!) di accedere a un’esperienza collettiva del mito.
Forse ammettendo semplicemente l’esistenza di una “mitologia di sinistra”, senza addossare tutte le colpe a una fantomatica “destra” (che non esisterebbe nemmeno se Montezemolo fosse costretto a leggersi Eliade), o affidarsi a una scappatoia teorica come l’inutilizzabile ipotesi della “macchina mitologica” (perduta irrimediabilmente nei ghirigori del post-strutturalismo), il pensiero di Jesi sarebbe potuto andare oltre i compulsatori ossessivi di riviste di moda e siti web pseudo-contestatari. Invece si è verificata una sorta di tecnicizzazione del mito jesiano, che oggi alimenta un reparto minore dell’industria culturale: ma rispetto alla brandizzazione e hipsterizzazione nostrane, una reductio ad Benjaminum in grande stile rappresenterebbe quanto meno un progresso (anche se vengono i brividi solo a pensarci).
Note:
[1] Con una simile sensibilità ci si accosta a Roland Barthes sperando che Miti d’oggi possa dire qualcosa più contro la sinistra che contro la destra – una speranza tuttavia vanificata dalle parole imbarazzanti con cui Barthes si giustificò per non aver mai parlato dei “miti di sinistra”: «L’analisi del mito che ho fatto nella parte conclusiva di Mythologies poggiava sul fatto che si trattava in effetti di parole, di discorsi. A proposito del problema dell’interpretazione politica del mito ho già risposto diverse volte alla domanda se il mito rimane sempre unicamente di destra. È una domanda che oggi si è fatta scottante: e se non scrivo delle nuove mythologies è proprio a causa di questa domanda: credo vi sia stato uno sviluppo, in questi ultimi vent’anni – Mythologies risale a circa venticinque anni fa – si è avuto uno sviluppo di alcuni miti, di alcuni elementi mitologici, a sinistra. Pur non essendo al potere, la Sinistra è diventata più forte, ha sviluppato un suo discorso che certamente porta in sé alcuni miti: vi sarebbe dunque spazio e modo di scrivere delle mythologies di destra e di sinistra, attualmente così fuse e, se non lo faccio, è perché non ho trovato modo di scrivere delle mythologies di sinistra senza avvantaggiare la destra, cosa che assolutamente non voglio. Dunque rimango in silenzio» (intervista a “Il Diaframma/Fotografia Italiana”, giugno 1978).
[2] Anche ammettendo che Eliade fosse un “nazi” fatto e finito, bisogna altresì riconoscere che Jesi giunge a identificarlo come tale nient’affatto pour cause: la sua analisi non rappresenta che un post hoc, indipendentemente dalle vicende politiche di cui l’intellettuale romeno fu protagonista.







