La riproposizione intermittente e frenetica degli scritti di Furio Jesi alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni, unita a uno stile frastagliato e a un eclettismo a tratti soverchiante, hanno impedito di rispondere all’unica questione che potrebbe comportare una sua rivalutazione al di là dell’idolatria dei suoi scialbi epigoni (che spesso assume proprio i lineamenti di “mito tecnicizzato”), ovvero se esiste (o se è esistito, o se potrebbe esistere) un mito di sinistra.
Jesi, in una celebre intervista a “L’Espresso” del giugno 1975 (ripubblicata nella nuova edizione di Cultura di destra, Nottetempo, Roma, 2011), risponde apparentemente in modo positivo: se la cultura di destra è quella in cui «si dichiara che esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola, innanzitutto Tradizione e Cultura ma anche Giustizia, Libertà, Rivoluzione» (p. 287), allora anche la sinistra rischia di lasciarsi plagiare dalle “idee senza parole” che governano le ideologie reazionarie.
In realtà Jesi sta proponendo un teorema che ricorre in tutta la sua opera: la mitologia di sinistra è sempre e comunque di destra, non solo perché il mito è continuamente suscettibile di tecnicizzazione, ma anche perché «la maggior parte del patrimonio culturale, anche di chi oggi non vuole affatto essere di destra, è residuo culturale di destra» . Perciò dei danni prodotti dai “miti di sinistra” è sempre e comunque responsabile… la destra!
Il percorso attraverso il quale Jesi giunge a tale conclusione è tutt’altro che lineare, tanto che nemmeno Enrico Manera, nella sua monografia (Furio Jesi. Mito, violenza, memoria, Carocci, Roma, 2012) ha potuto ricostruirlo in modo esauriente. Tentiamo tuttavia di riassumerlo per sommi capi: superata la giovanile infatuazione per Frobenius, che lo aveva condotto a suggestioni irrazionalistiche, il primo Jesi opera una “ripulitura” dai presupposti metafisici delle tradizionali teorie sul mito, riportando il paideuma sulla terra e innestando su di esso una forma di marxismo eterodosso.
Questa “secolarizzazione” la si percepisce progressivamente anche nelle espressioni utilizzate: non più “miti” ma “motivi mitici” e “materiali mitologici”; non più “archetipi”, ma “connessioni archetipiche” e “prototipi”; non più “scienza del mito” ma “grammatica dell’immaginario” e “fenomenologia della cultura”. È con tale disposizione mentale che Jesi recepisce la dicotomia di Kerényi tra “mito genuino” e “mito tecnicizzato”, modellandola sulla propria militanza politica (è la destra a manipolare/tecnicizzare i miti, mentre la mitopoiesi anarco-socialista ha come scopo l’emancipazione della società).
Dopo la rottura col maestro ungherese, Jesi matura la convinzione che non esiste alcun “mito genuino” ma affinché la materia dei suoi studi non muoia sotto i ferri della “dissezione storicistica”, elabora l’artificio teorico della “macchina mitologica”, formula con la quale egli vuole identificare «il processo sociale e culturale la cui funzione è, in ogni tempo, intrattenere un rapporto con l’invisibile mediante la produzione del “mito” come materiale primitivo, originale, vivo» (Manera, p. 94).
Che si tratti di un’espediente lo si evince dal fatto che, nonostante l’Autore affermi che «la “macchina mitologica” risulta […] mitologica perché rientra fra i materiali della mitologia, non perché serva a conoscerli» (Materiali mitologici [1979], Einaudi, Torino, 2001, p. 174), essa rappresenterà negli ultimi scritti lo strumento definitivo attraverso il quale studiare il mito: «La macchina mitologica pone nelle nostre mani, nello stesso tempo, un modello gnoseologico e uno specchio del nostro inganno» (Materiali mitologici, p. 182).
A livello speculativo, ciò significa che tale modello finisce per rimpiazzare il posto occupato dal “mito genuino” che Jesi ha espunto –per motivi poco comprensibili– dalla sua analisi. È vero che grazie a questo strumento epistemologico lo studioso può ora approcciare i materiali mitologici continuando a «pensare “a sinistra”», restando quindi fedele a «una rivoluzione cognitiva che è prima di tutto capacità di demistificare ogni ideologia» (Manera, p. 128), tuttavia la decisione di «escludere l’esistenza di un mito genuino» (ivi, p. 94) lascia cadere una serie di questioni che non hanno mai trovato risposta: per esempio, se le classi subalterne possano servirsi del mito senza essere accusate di far ricorso a «uno strumento intrinsecamente reazionario» (Letteratura e mito, Einaudi, Torino, 2002, p. 42).
Jesi è consapevole che «la sola ragione [è] insufficiente per la trasformazione profonda del tessuto politico di una società» (Manera, p. 40) e che senza il carburante adatto (magari quel “tonico potente” di cui parlava Cesare Pavese) la “macchina” non va da nessuna parte [1]. Se poi tale modello serve a «riconoscere il mito come “mito dell’uomo”, prodotto culturale dell’umano sull’umano» (ivi, p. 104) e captare «la dimensione profonda dell’inconscio culturale collettivo», per poi «restituirla in forma umana come mitologia dell’uomo contro la tecnicizzazione che simula l’origine extraumana» (ivi, p. 44), allora si può dedurre tra le righe l’auspicio inespresso che la “macchina mitologica” sorpassi la teoria per impennare verso la militanza tout court.
Non è fuori luogo osservare che tale “programma” assomiglia in modo incredibile al proposito pavesiano di “ridurre i miti a chiarezza”, tradotto immediatamente in modello di condotta politica:
«Nel corso della razionalizzazione e scientifizzazione di tutta la vita di un popolo come la propone il socialismo, proprio gli elementi culturali più rozzi, indifferenziati, mistici, magici, prescientifici ecc. verrebbero studiati, compresi e rivendicati» (Discussioni etnologiche, “Cultura e Realtà”, n. 1, maggio-giugno 1950; ora in Saggi letterari, Einaudi, Torino, 1951, p. 323) [2].
Eppure è proprio su questo punto che Jesi fraintende totalmente lo scrittore piemontese, accusandolo assieme a Kerényi di essere un occulto praticante della religio mortis e bollando il “suo” comunismo come riflesso del “mito del sacrificio” (Letteratura e mito, p. 173).
Un tale fraintendimento non si spiega se non col rifiuto ostinato da parte di Jesi di riconoscere una “mitologia di sinistra”, che lo costrinse ad addossare tutti i misfatti del mondo alla Cultura di destra (che non solo va da Eliade a Montezemolo, ma inghiotte pure il povero Cesare Pavese, martirizzato per la seconda volta da un altro caro “compagno”). Se la nostra vis interpretandi fosse altrettanto meschina, saremmo costretti a ipotizzare dei motivi di risentimento personale nei confronti del suo antico maestro [3] per la veemenza con cui Jesi a un certo punto rifiuta qualsiasi possibilità di un “mito genuino”. Ma non lo faremo, poiché in fondo anche Jesi è stato eccezionalmente martirizzato dalla progenie dei discepoli acquisiti malgré lui. Ci limitiamo a osservare, parafrasando un noto aforisma, che alla fine sono tutti mitografi col mito degli altri.
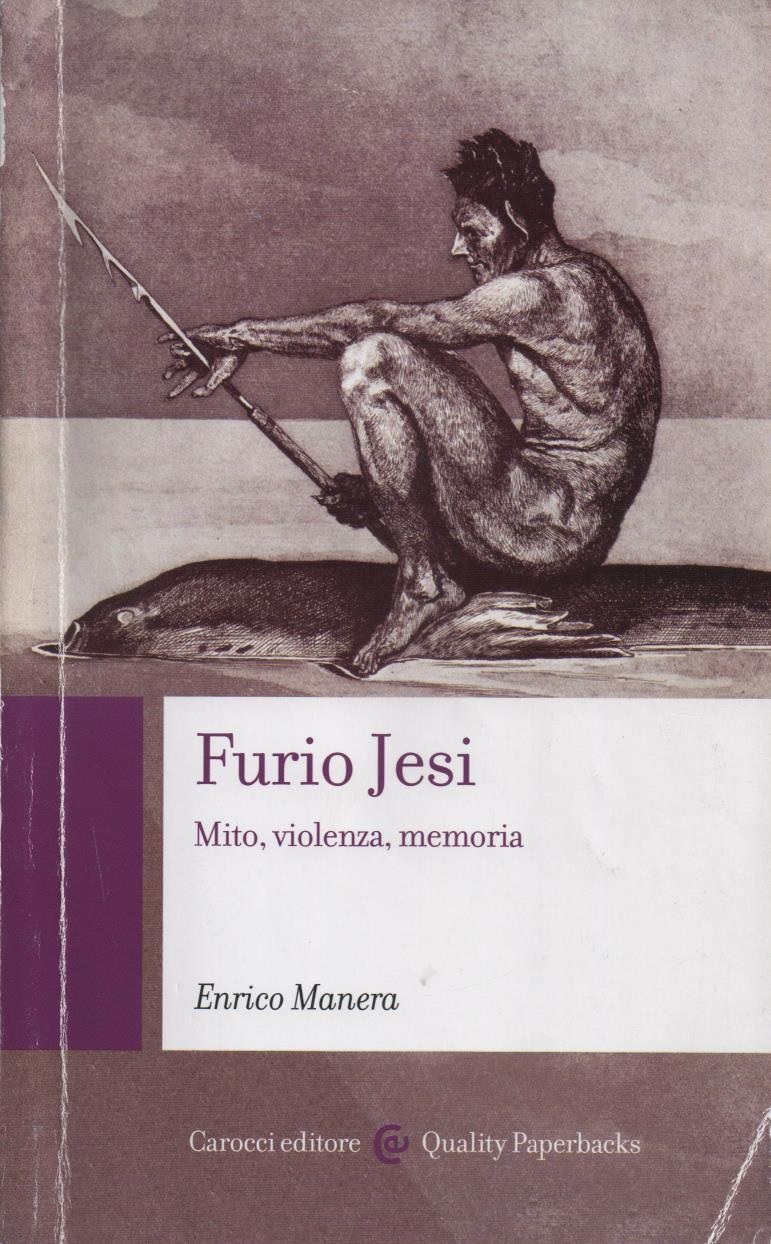
Note:
[1] Come scriveva nell’introduzione a un’antologia sul tema della festa del 1977 (“Conoscibilità della festa”, ora ne Il tempo della festa, Nottetempo, Roma, 2013, p. 106):
«Occorre distruggere non le macchine in sé, le quali si riformerebbero come la testa dell’idra, bensì la situazione che rende vere e produttive le macchine. La possibilità di questa distruzione è esclusivamente politica; il suo rischio, dal punto di vista gnoseologico, è che le macchine siano davvero vuote e che dunque, dimostrata infine la loro vacuità, essa stessa si imponga come una paradossale macchina negativa che produce il nulla dal nulla».
[2] Che poi Pavese non avesse le idee chiare su come mettere in pratica il suo ambizioso progetto (come dimostra quanto scrisse a De Martino in una lettera del dicembre 1949: «Studiare i primitivi per scoprire un valore nelle loro magie e fantasie, o per meglio averli in mano e marxistizzarli?»), è un altro discorso (per la lettera. cfr. La collana viola. Lettere 1945-1950, Bollati Boringhieri, Torino, 1991, p. 169).
[3] I toni dell’ultima lettera a Kerényi (16 maggio 1968) sono effettivamente sconcertanti (cfr. Demone e mito. Carteggio 1964-1968, Quodlibet, Macerata, 1999, p. 118):
«Se la sorte vuole che io sia costretto a rivolgere queste parole alla persona che ho considerato maestro dall’adolescenza ciò significa che i tempi sono particolarmente oscuri. […],. E probabilmente sarà una crisi che si dispiegherà nelle vie e che si combatterà con le armi; una crisi in cui anche maestro e allievo, e padre e figlio, si ritroveranno concretamente nemici, nell’una e nell’altra schiera».







