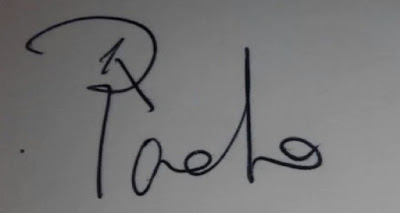Su Oppenheimer ho già detto la mia e non mi sembra il caso di ripetermi. D’altro canto non mi interessa neppure polemizzare con chi si spella le mani, poiché la trovo una reazione non dettata da motivazioni estetiche o di altro tipo, ma più che altro “psicologiche”: illudersi di aver assistito al “filmone” sembra un espediente per difendere un ordine mentale in cui era Hollywood a modellare interamente il nostro immaginario.
Oppenheimer: il kolossal che gli americani non possono più permettersi
Al di là tuttavia delle sensazioni soggettive, è un fatto che se anche l’opera di Nolan fosse un capolavoro, sarebbe in ogni caso un prodotto pensato da americani per un pubblico americano: una riflessione sulla propria storia non a caso incentrata sulla questione del processo allo scienziato, scelta che pare esprimere un certo affievolirsi dell’epos a stelle e strisce (e che peraltro rende la pellicola, come è stato argutamente notato, simile a “una puntata non divertente di Un giorno in pretura“).
È soprattutto il momento che avrebbe dovuto rappresentare l’acme di qualsiasi opera dedicata a Oppenheimer, l’enunciazione del suo motto (“[Now] I Am Become Death, the Destroyer of Worlds”), a suscitare disincanto, se non frustrazione: la “cifra” del personaggio liquidata prima in un amplesso con l’amante e poi in un sussurro che sembra già di per sé una parodia.
Completamente “bucata”, invece, l’espressione più iconica della frase, immortalata in un’intervista per il documentario The Decision to Drop the Bomb, prodotto dalla NBC nel 1965.
Nel suo intervento, registrato a quasi vent’anni dal primo test, Oppenheimer attribuisce erroneamente la citazione a Vishnu e non a Krishna (che è comunque l’ottavo avatar di tale divinità) e parla apertamente di duty, cioè di “dovere”, la miglior traduzione in inglese, dalla sua prospettiva, del concetto di dharma.
Con questa citazione dal (o dalla) Bhagavad Gita, lo scienziato sta sostanzialmente affermando di aver fatto il proprio “dovere”, cioè di aver adempiuto al dharma della propria “casta” (intesa ovviamente in termini di professione, capacità, esperienza ecc…).
Questo già potrebbe dir molto sulle “lacrime di coccodrillo” versate nei decenni successivi, posto che anche in tal caso l’atteggiamento del Nostro genera enormi amibiguità, non solo dal punto di vista morale: il suo unico vero “rammarico” è probabilmente rappresentato dall’essersi rifiutato di intervenire sull’uso politico dell’atomica (in sé elemento buono, positivo, se non “santo”), un compito che tuttavia non era suo “dovere” adempiere, sempre dai presupposti pseudo-induisti che lo ispiravano (per fare un esempio, nei suoi anni da comunista giustificò il patto Molotov-Ribbentrop perché convinto che Stalin appartenesse a un’altra “casta” e dunque stesse prendendo la decisione giusta).
Se il film si fosse basato, come avrebbe dovuto, solo su questa citazione, forse avremmo avuto un qualcosa di decente, magari persino un accenno a una reale riflessione sulla propria storia (che invece in tal caso viene rappresentata esclusivamente nello scontro tra Oppenheimer e Strauss, tanto immaginario quanto quello tra Mozart e Salieri, apertamente rivendicata come fonte d’ispirazione dal regista).
Un altro dettaglio interessante sull’I Am Become Death riguarda il primo testimone ad averlo registrato: si tratta, almeno da quel che risulta dalle fonti disponibili, di William Leonard Laurence, giornalista di origine ebraica (nato Leib Wolf Siew) che fu l’opinionista di punta della cosiddetta “era atomica” e a causa di ciò oggi viene perlopiù ricordato per aver liquidato sul “New York Times” gli effetti letali delle radiazioni conseguenti ai bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki (a quest’ultimo aveva persino assistito a bordo del bombardiere) come “propaganda giapponese”.
Laurence intervistò Oppenheimer a Los Alamos subito dopo il primo test atomico (al quale aveva partecipato come spettatore) e in seguito affermò di non aver mai dimenticato “l’impatto sconvolgente” di quella citazione, anche se stranamente si rifiutò di riportarla per anni, sia in un resoconto del settembre del 1945 sia in una Story of the Atomic Bomb pubblicata a New York nel 1946 (la prima volta che ne fa menzione è nel volume Men and Atoms del 1959). Considerando gli intenti del reporter, tale omissis potrebbe essere più significativo di quel che sembri, anche meditando sull’impatto immediato che avrebbe potuto avere sull’opinione pubblica, e sui sentimenti che ancora potrebbe suscitare qualora inserito nel giusto contesto…