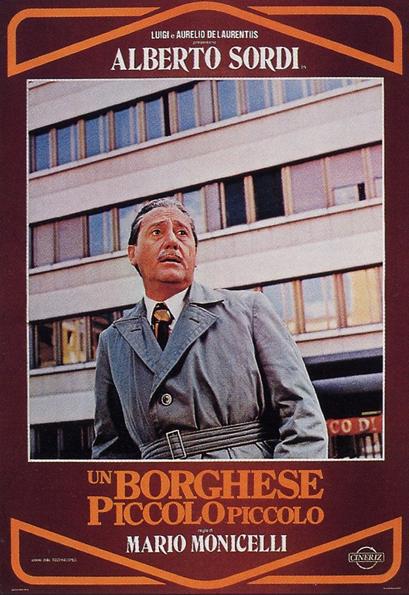L’unico motivo per cui mi verrebbe da scrivere un necrologio per un grande artista è quella possibilità quasi immediata, offerta in primo luogo dal bailamme del prefichismo internettiano (versione “atomica” di quello giornalistico), di impossessarsi della sua opera e dirne in pratica ciò che si vuole (ci si augura sempre entro i limiti della pietà e del rispetto).
Forte di questo “scudo”, sento di poter dire qualcosa su Ermanno Olmi, venuto a mancare ieri all’età di 86 anni. Finora da queste parti ho parlato di un solo suo film, Durante l’estate (1971), evidenziandone una dimensione “metapolitica”, quasi costante nei film che considero i suoi migliori (in pratica quelli in dialetto), e che si potrebbe sintetizzare nel concetto marxiano di passaggio da preistoria e storia. In tal caso la classe di cui si parla è soprattutto letteraria, ma non così tanto da poterla ricondurre interamente agli “umili” di manzoniana memoria, i cui unici momenti da veri protagonisti si riducono peraltro ai saccheggi e ai tumulti (pare che il solo ad accorgersene, nelle vesti di critico, sia stato Gramsci).
Al contrario, nello strepitoso esordio Il posto (1961) è proprio la dimensione individuale dell’intreccio a prevalere sull’affresco minimale della “transizione epocale” (in sostanza dalla campagna alla città), decisamente in contrasto, per come la vedo io, rispetto alle intenzioni dell’autore. E’ ovvio che ogni opera riflette, anche solo per necessità, l’esprit du temps, tuttavia è sempre disdicevole ridurre l’artista a “cantore”, quando invece tutta la paranoia sul rapporto struttura/sovrastruttura (altro lessico marxista caduto opportunamente nell’insignificanza) dovrebbe essere come minimo rimandata alle condizioni di possibilità dell’esistenza stessa di un “cantore”.
Ma non facciamola troppo lunga: la “morale” è che, a onta del titolo, Il posto parla meno di lavoro che di bohème. A trarre in inganno non è solo l’occhio da documentarista che Olmi si era fatto nei suoi deliziosi cortometraggi dei primordi, ma anche la sensibilità lombarda nei confronti dell’operosità, in pura antitesi con qualsiasi ridicolaggine stile downshifting (tendenza che purtroppo sembra emergere nell’Olmi più “moralistico” e “spiritualizzante”, del quale, se non l’ho già detto, preferirei non parlare). E’ un bene, col senno di poi, che nessuno se ne sia accorto, poiché in tal modo il regista ha potuto costantemente godere della via di fuga del manzonismo, se non addirittura del folklore o dell’idillio: perché, per lo spettatore che proietta fuor di sé quegli “umili”, anche L’albero degli zoccoli è pura arcadia senza “lezione” alcuna, perduta tutta nell’estetica amorale del “buon tempo antico”.
Perciò sono convinto che il motivo delle genealogie plebee, chiamato in causa parlando di Durante l’estate, sia un utile filo conduttore per dare un senso a buona parte dell’opera dell’Olmi, escludendo appunto quella “spiritualizzazione” troppo segnata dalla senilità per esser presa sul serio (ma ancora emerge, per esempio, ne Il mestiere delle armi). Credo sarà questa la ragione per cui ricorderemo Ermanno Olmi: aver creato le condizioni di possibilità del “ricordo” stesso anche da parte di chi non aveva memoria alcuna, al di là dei registri parrocchiali, degli archivi etnologici e delle inchieste sugli usi e costumi popolari.