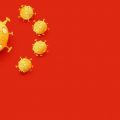The Coronavirus Could Reshape Global Order
(Foreign Affairs, 18 marzo 2020)

Dopo aver costretto centinaia di milioni di persone all’auto-isolamento in tutto il mondo, la nuova pandemia di coronavirus è diventata un evento davvero globale. E mentre le implicazioni geopolitiche dovrebbero apparire secondarie rispetto alle questioni di salute e sicurezza, tali conseguenze potrebbero, sulla lunga distanza, rivelarsi altrettanto significative soprattutto nei confronti della posizione globale degli Stati Uniti. I sistemi global hanno infatti la tendenza iniziale a mutare per gradi, finendo poi per modificarsi all’improvviso. La crisi di Suez del 1956, per esempio, ha rivelato la decadenza dell’imperialismo britannico e ne ha segnato la fine come potere globale. Ora i politici statunitensi dovrebbero rendersi conto che se gli Stati Uniti non si ergono contro le attuali avversità, la pandemia del coronavirus potrebbe segnare un altro Suez moment.
Ormai è chiaro a tutti (a parte ai più ideologizzati) che la risposta iniziale di Washington è stata fallimentare. I passi falsi delle sue istituzioni chiave, dalla Casa Bianca e dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hanno minato la fiducia nelle capacità degli Stati Uniti. Le dichiarazioni pubbliche di Donald Trump, siano esse ufficiali o twittate, sono servite perlopiù a diffondere confusione e incertezza. Sia il settore pubblico che quello privato si sono dimostrati poco preparati a rendere immediatamente disponibili gli strumenti per fermare la pandemia. Che, a livello internazionale, ha incentivato la tendenza di Trump a “far da solo”, mettendo in luce l’incapacità di Washington di offrire una risposta globale.
Lo status degli Stati Uniti come leader globale negli ultimi settant’anni si è basato non solo su prosperità e potere, ma anche sulla legittimità derivata dalla governance interna, sulla fornitura di beni a livello internazionale e sulla capacità di gestire risposte globali alle crisi. La pandemia di coronavirus sta mettendo alla prova tutti e tre gli elementi della leadership statunitense. Finora, gli Stati Uniti stanno fallendo in questa prova.
Mentre Washington vacilla, Pechino approfitta abilmente degli spazi creati dagli errori americani, posizionandosi nel vuoto creatosi come leader globale contro la pandemia. La Cina mette a punto il proprio “sistema”, fornisce assistenza materiale ad altri Paesi e arriva anche a disfare e fare governi. In ogni caso è difficile valutare al momento la chutzpah (sic) delle autorità cinesi. Dopo tutto sono stati proprio i passi falsi di Pechino (soprattutto la decisione di insabbiare i dati sulla diffusione dell’epidemia) a contribuire a creare la crisi che ora colpisce il mondo. Eppure Pechino capisce che se riesce ad apparire come leader e al contempo far sembrare Washington incapace o indolente, tale percezione potrebbe modificare radicalmente la posizione degli Stati Uniti nella politica globale e nella competizione per il dominio nel XXI secolo.
Subito dopo lo scoppio della pandemia gli errori dei leader cinesi hanno suscitato numerosi dubbi sulla autorità globale del loro Paese. Il virus è stato identificato per la prima volta nel novembre 2019 a Wuhan, ma i funzionari oltre a tacere per mesi hanno anche incarcerato i medici che lo hanno segnalato, ritardando così di settimane le misure necessarie a rendere consapevole del pericolo la popolazione (come fermare ogni tipo di movimento e consentire lo screening di massa). Anche quando è emersa la gravità della crisi, le autorità cinesi hanno continuato a controllare le informazioni da far trapelare, evitando l’assistenza del CDC, limitato le ispezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Wuhan, probabilmente ribassando le stime su infezioni e decessi attraverso la modifica continua dei criteri per la identificazioni di nuovi casi di coronavirus, in un tentativo deliberato di manipolare le statistiche ufficiali sul contagio.
Con l’aggravarsi della crisi nei mesi di gennaio e febbraio, alcuni hanno ipotizzato che il coronavirus possa addirittura minare la leadership del Partito comunista cinese: si è parlato di “Chernobyl cinese” e Li Wenliang, il medico che ha fatto trapelare le prime indiscrezioni sul COVID-19 e poi è deceduto a causa del virus stesso, è stato paragonato a quell’uomo che sfidò un carrarmato in piazza Tienanmen.
Tuttavia agli inizi di marzo la Cina proclamava vittoria, confermando la bontà di mezzi come la quarantena di massa, il divieto di spostamento e lo shutdown completo. Le statistiche ufficiali ora infatti riportano che i nuovi casi giornalieri sono scesi a una sola cifra dalle centinaia dei primi di febbraio. Con grande stupore da parte degli osservatori, Xi Jinping, rimasto a lungo insolitamente silenzioso, si è messo al centro della scena ed è andato a visitare personalmente Wuhan.
Anche se la vita in Cina non è ancora tornata alla normalità (e nonostante i dubbi sull’accuratezza delle statistiche cinesi), Pechino vuole trasformare i primi segnali di successo in una narrazione più ampia da divulgare al resto del mondo, in modo da fare della della Cina la protagonista della prossima ripresa globale e al contempo far dimenticare la pessima gestione della crisi.
Una parte controversa della “narrazione” è il presunto successo di Pechino nella lotta contro il virus. Un flusso costante di articoli di propaganda, tweet e messaggistica in tutte le lingue ha consentito alla Cina di raggiungere i suoi obiettivi e di esaltare l’efficacia dei suoi metodi di governo: “La forza, l’efficienza e la velocità della Cina in questa lotta sono state elogiate da tutti”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Zhao Lijian. “La Cina”, ha aggiunto, “ha sancito nuovi standard per il contrasto globale all’epidemia”. Le autorità centrali hanno istituito uno stretto controllo sull’informazione e una rigorosa disciplina presso gli organi statali per eliminare ogni voce contraria.
Questi messaggi traggono vantaggio dal contrasto implicito tra i metodi “occidentali” per combattere il virus, in particolare per quanto concerne gli Stati Uniti, dato che Washington non è riuscita a produrre un numero adeguato di kit diagnostici, il che lascia intendere che siano stati sottoposti al test pochissimi americani, o che addirittura l’amministrazione Trump sia decisa a smantellare qualsiasi infrastruttura di risposta alla pandemia. Pechino ha colto l’opportunità fornita dal disordine americano mandando avanti i propri media e i propri diplomatici a ricordare al mondo intero gli sforzi cinesi e criticare “l’irresponsabilità e l’incompetenza della cosiddetta élite politica di Washington” come ha scritto in un editoriale l’agenzia di stampa statale Xinhua.
I funzionari cinesi e i media statali hanno anche insistito sul fatto che il coronavirus non sia di fatto partito dalla Cina (nonostante le prove schiaccianti del contrario) per ridurre le proprie responsabilità. Questa mossa sa di vera e propria disinformatsija in pieno stile sovietico, con il portavoce del Ministero degli Esteri che condivide articoli complottistici di bassa lega in cui si accusa l’esercito statunitense di aver portato il coronavirus a Wuhan. Queste iniziative, unite all’espulsione di massa degli inviati di tre importanti giornali americani, danneggiano le pretese egemoniche della Cina.
Xi Jingping capisce che fornire merci a livello globale può danneggiare le credenziali di una potenza in ascesa: non a caso il leader cinese ha impiegato anni a formare gli apparati di politica estera per dirigere una riforma della governance globale, e il coronavirus offre l’opportunità di tradurre in pratica la teoria. Pensiamo all’assistenza materiale (mascherine, respiratori, ventilatori e farmaci) così tanto ostentata: all’inizio della crisi, la Cina ha acquistato e prodotto (oltre a ricevere come aiuto) grandi quantità dei beni che ora è in grado di distribuire agli altri.
Quando nessuno Stato europeo ha risposto all’appello disperato dell’Italia per attrezzature mediche e dispositivi di protezione, la Cina si è impegnata a inviare 1.000 ventilatori, due milioni di mascherine, 100.000 respiratori, 20.000 tute protettive e 50.000 kit di prova. Pechino ha anche inviato squadre mediche e 250.000 maschere in Iran e rifornimenti alla Serbia, il cui presidente ha liquidato la solidarietà europea come “una favola” e ha proclamato che “l’unico Paese in grado di aiutarci ora è la Cina”. Il patrono di Alibaba Jack Ma ha promesso di inviare grandi quantità kit e maschere negli Stati Uniti, oltre a 20.000 kit e 100.000 maschere per ogni Paese africano.
Il vantaggio di Pechino nell’assistenza materiale dipende dal semplice fatto che gran parte dei materiali indispensabili a combattere il coronavirus è… Made in China. Se la Cina era già il più grande produttore di maschere chirurgiche, ora la mobilitazione industriale da tempi di guerra ha fatto decuplicare il settore. Il gigante asiatico produce anche la metà dei respiratori N95 fondamentali per la sicurezza degli operatori sanitari (infatti ha costretto le fabbriche straniere a venderli direttamente al governo), il che offre a Pechino di un altro strumento di pressione, in forma di attrezzature mediche. Lo stesso discorso per gli antibiotici, fondamentali per affrontare le infezioni secondarie, dei quali i cinesi producono la maggioranza dei principi attivi farmaceutici necessari a produrli.
Gli Stati Uniti, al contrario, non hanno la capacità di soddisfare molte delle loro richieste, per non dire della possibilità di fornire aiuti ad altri Paesi in crisi. Il quadro è fosco: la Strategic National Stockpile, la riserva nazionale di forniture mediche essenziali, detiene solo l’1% delle maschere e dei respiratori e forse il 10% dei ventilatori necessari. Il resto dovrà essere importato dalla Cina, oppure reso disponibili da un rapido aumento della produzione interna. Stesso discorso, come si diceva più sopra, per gli antibiotici: la quota cinese nel mercato statunitense è superiore al 95% e la maggior parte dei principi attivi non può essere prodotta sul mercato interno. Anche se Washington ha offerto assistenza alla Cina e ad altri all’inizio della pandemia, con l’accrescersi dei suoi bisogni forse non sarà più in grado di farlo; al contrario, Pechino può dare una mano proprio nel momento in cui le necessità a livello globale aumentano.
Una risposta valida alla crisi, tuttavia, non riguarda solo i beni materiali. Durante l’epidemia di ebola del 2014-15, gli Stati Uniti guidarono una coalizione per contrastare la diffusione della malattia: l’amministrazione Trump non ha finora prodotto un simile sforzo per rispondere alla pandemia. Anche il coordinamento con gli alleati è mancato. Washington, ad esempio, sembra non aver dato alcun preavviso agli alleati europei prima vietare i viaggi dall’Europa.
La Cina, al contrario, ha intrapreso una possente campagna diplomatica coinvolgendo decine di paesi e centinaia di funzionari e condividendo informazioni sulla pandemia e la propria esperienza nella lotta contro di essa. Come vuole la diplomazia cinese, questi tentativi di cooperazione sono in gran parte condotti a livello regionale o attraverso organismi regionali. Comprendono le conferenze con gli Stati dell’Europa centrale e orientale attraverso il meccanismo 17+1, col segretariato dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, con dieci Stati delle isole del Pacifico e con altri raggruppamenti in Africa, Europa e Asia. E la Cina sta lavorando alacremente per propagandare tali iniziative. Praticamente tutte le storie in prima pagina dei suoi organi informativi per il pubblico straniero pubblicizzano l’impegno della Cina per aiutare il mondo con beni e informazioni, sottolineando la superiorità dell’approccio di Pechino.
La principale risorsa della Cina nel perseguimento della leadership globale, non solo per quanto riguarda il coronavrius, è l’inadeguatezza americana, unita al ripiegamento verso l’intero. e il focus interno della politica statunitense. Il successo finale per la Cina, quindi, dipenderà tanto da ciò che accadrà a Washington quanto a Pechino. Nella crisi attuale, per Washington è ancora possibile invertire la tendenza qualora si dimostrasse in grado di fare quel che ci si aspetta da un leader: gestire il problema “in casa propria”, fornire assistenza globale e coordinare una risposta a livello internazionale
Il primo di questi compiti – arrestare la diffusione della pandemia e proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili negli Stati Uniti – è più impellente e riguarda perlopiù la governance interna piuttosto che la geopolitica. Il modo in cui Washington si muoverà avrà però inevitabili implicazioni geopolitiche, e non solo nella misura in cui ristabilirà (o meno) la fiducia negli USA. Ad esempio, se il governo federale sosterrà immediatamente la produzione interna di maschere, respiratori e ventilatori – una risposta adeguata ai “tempi di guerra” imposto dalla pandemia – ciò salverà le vite di molti americani e aiuterà altri nel mondo sovvenendo alla scarsità di materiale.
Mentre gli Stati Uniti non sono al momento in grado di soddisfare le impellenti necessità materiali, il loro vantaggio scientifico e biotecnologico può essere determinante per trovare una vera soluzione alla crisi: un vaccino. Il governo degli Stati Uniti può sostenere la ricerca fornendo incentivi ai laboratori e alle aziende statunitensi, per intraprendere un Manhattan Project volto alla produzione in massa di un vaccino. Poiché questi sforzi sono costosi e richiedono ingenti investimenti, un generoso finanziamento governativo e dei bonus per la produzione di vaccini potrebbero fare la differenza. E vale la pena notare che, nonostante la cattiva gestione di Washington, i governi statali e locali, le organizzazioni no-profit e religiose, le università e le aziende, non aspettano il governo federale per agire. Le aziende e i ricercatori finanziati dagli Stati Uniti stanno già studiando un vaccino, anche se, anche nel migliore delle ipotesi, ci vorrà un po’ di tempo prima che sia pronto per un uso diffuso.
Eppure, anche se si concentra sui problemi all’interno dei confini nazionali, Washington non può semplicemente ignorare la necessità di una risposta globale coordinata. Solo una forte leadership può risolvere le questioni globali legate alle restrizioni di viaggio, alla condivisione delle informazioni e al flusso di beni materiali indispensabili. Gli Stati Uniti hanno svolto il ruolo di leader per decenni e devono tornare a farlo.
Tale leadership richiederà anche una cooperazione fattuale con la Cina, piuttosto che una guerra di “narrazioni” su chi se l’è cavata meglio. C’è poco da guadagnare nell’enfatizzare ripetutamente le origini del coronavirus (già ampiamente conosciute nonostante la propaganda cinese) o scambiarsi scaramucce diplomatiche. Nonostante i funzionari cinesi accusano l’esercito statunitense di aver diffuso il virus e ridicolizzano le iniziative degli americani, Washington dovrebbe reagire solo quando necessario e in generale resistere alla tentazione di mettere la Cina al centro della sua propaganda. La maggior parte dei paesi che affronta la sfida preferirebbe ascoltare un messaggio che sottolinea la gravità di una sfida globale collettiva e indica percorsi da seguire (compresi esempi di successo di società democratiche come Taiwan e Corea del Sud). Washington e Pechino potrebbero fare molto assieme, a beneficio del mondo intero: coordinare la ricerca sui vaccini e le sperimentazioni cliniche nonché lo stimolo fiscale; condividere informazioni; collaborare alla mobilitazione industriale (per esempio volta alla produzione di componenti respiratori indispensabili); e offrire assistenza congiunta ad altri.
In definitiva, il coronavirus potrebbe anche servire da campanello d’allarme e favorire qualche progresso su altre sfide globali che richiedono la cooperazione tra Stati Uniti e Cina, come i cambiamenti climatici. Un simile passo non sarebbe visto come un cedimento al potere cinese. Piuttosto, aiuterebbe in qualche modo il ripristino della fiducia nel futuro della leadership degli Stati Uniti. Nell’attuale crisi, come oggi più in generale nella geopolitica, gli Stati Uniti possono cavarsela.