Periodicamente, in seguito alla solita rivolta in una capitale europea da parte dei cosiddetti “immigrati di seconda (o terza) generazione”, vuoi perché una nazionale di calcio nordafricana ha vinto una partita in un torneo internazionale, vuoi perché la polizia ha perquisito/ferito/ucciso (perlopiù accidentalmente, proprio per evitare certe spiacevoli situazioni) qualche bravissimo ragazzo che i generazione-secondisti considerano uno dei “loro”, il sistema politico-mediatico rispolvera l’inossidabile leitmotiv della fatidica “integrazione”, riproponendolo nelle stesse medesime forme con cui lo propina da decenni, anche a fronte dei cambiamenti epocali che hanno interessato- per non dire travolto e distrutto- le nostre collettività dal punto di vista sociale, culturale, etnico e politico.
E persino quando tenta una rilettura del concetto, come fa il giornalista di origine ebraica Stefano Montefiori sul “Corriere della Sera” di ieri (3 luglio 2023), parlando di un fallimento del “modello universalista e assimilazionista francese” rispetto al “multiculturalismo all’anglosassone”, il mainstream riesce comunque a dire la cosa sbagliata, in tal caso accreditando un paradigma ottusamente relativista e politicamente corretto che non ha salvato Londra, nel 1995 come nel 2011, dalle proteste “alla francese”.
È preferibile dunque partire dal lontano, seppur affidandosi ancora al “Corrierone” che è sempre sul pezzo, in particolare negli anni ’30 del secolo scorso (più precisamente il 7 marzo 1933) quando in un editoriale in prima pagina descrisse minuziosamente il battesimo di Bubaker Abd el Gaden Tuhati, “bambino color cioccolata” (in realtà un “giovane arabo venticinquenne”) proveniente dalla misteriosa “oasi di Zardur”, nelle vere e proprie forme di un rituale di italianizzazione.
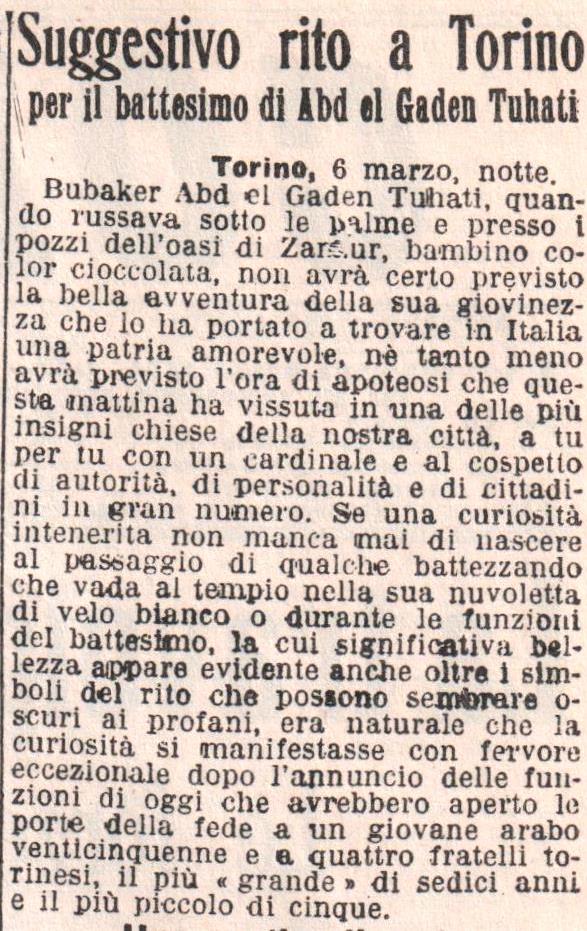
La cronaca di quella “ora di apoteosi”, svoltasi si svolse nella chiesa di San Carlo a Torino, alla presenza dell’Arcivescovo, dei generali, dei segretari federali, dei seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dei consoli e dei rappresentanti dell’Associazione nazionale combattenti coloniali, si concludeva con questo paragrafo:
«Ed ecco presso il fonte battesimale il giovane arabo dal bel volto animoso e i suoi quattro compagni. Le frasi del rito risuonavano chiaramente. Alle domande del celebrante non rispondeva questa volta le voci dei padrini e delle madrine come nei riti consueti quando il battezzando non è davvero in grado di rispondere spontaneamente. Le affermazioni di rinuncia e di fede erano naturalmente pronunciate dai catecumeni stessi con serena sicurezza, tanto che il loro dialogo con il presule cresceva a poco a poco in fervore e in tono, acquistando un indicibile fascino, un senso di sincerità profonda, di realtà viva e presente, nonostante l’antichità remota delle formule e l’arcaica nobiltà del latino liturgico.
[…] Subito dopo il prelato e i nuovi cattolici sono ritornati all’altare maggiore dove Bubaker, che d’ora innanzi si chiamerà Giovanni, ha ricevuto il sacramento della Cresima e dell’Eucaristia.
Celebrata la messa, l’arcivescovo ha quindi rivolto ai cinque battezzati paterne parole. Dinanzi al tempio intanto altra folla s’era accalcata e all’uscita del giovane arabo gli ha improvvisato una dimostrazione di simpatia.
Giovanni Abd el Gaden Tuhati ha sorriso, ha salutato con la mano, poi si allontanato attorniato da un gruppo di fascisti, compagni suoi nella fede che anch’egli da anni professa, con ammirevole dedizione per l’Italia di Mussolini».
A ben vedere, è questa a tutti gli effetti l’unica forma possibile di integrazione, persino intendendo l’espressione nel significato sclerotizzatosi a seguito delle ondate migratorie che hanno investito l’Italia e l’Europa. L’utilizzo del termine, anche dal punto di vista etimologico, sottintende infatti l’esistenza di un “intero” del quale l’estraneo possa aspirare a far parte: tuttavia, ciò non implica che tale “intero” sia rappresentato da una collettività multietnica, democratica, socialista, liberale, solidale ecc
Al contrario, sembra che all’enfasi posta sulla necessità di “integrare” corrisponda il bisogno parallelo di trovare idee sempre più “forti” con le quali tenere assieme una società continuamente minacciata da tensioni conseguite alla frammentazione etnico-religiosa. A un certo punto pare inevitabile che, di fronte all’apporto inarrestabile di culture “altre”, i principi fondanti assurgano alla statura di dogma.
Anche se i tempi sembrerebbero finalmente maturi per tracciare un bilancio su vantaggi e svantaggi dell’immigrazione di massa nel Bel Paese (allo scopo servirebbe forse un libro di demografia per l’uomo comune), al momento potremmo -ancora- limitarci a osservare quanto accade a nord del Vecchio Continente, precisamente tra le nazioni rappresentanti il mitizzato “Modello Scandinavo”.
Si è assistito, soprattutto negli ultimi anni, al tracollo di quella “socialdemocrazia di lusso” sorta per una serie di straordinarie coincidenze storiche in Svezia, Danimarca e Finlandia: al di là della ragione palese, identificata ormai sia destra che sinistra nel tracollo del sistema previdenziale causato da welfare magnetism, sarebbe utile concentrarsi anche sull’irrigidimento di tale “modello”, per giunta acuito nel caso particolare da ciò che gli anglosassoni definiscono virtue signalling (=”esibizionismo morale”).
Pensiamo alla miserabile Svezia, passata da salotto del benessere a bassofondo di una violenza urbana dai tratti distopici: è difficile negare che in tale deriva non abbia avuto un ruolo l’obbligo di trasformare l’integrazione da obiettivo secondario a fulcro del proprio sistema. Evidentemente il gioco non ha funzionato, perché in fondo nessun essere umano si è mai posto come scopo quello di diventare “socialdemocratico”.
Alla peggio qualche africano troverebbe forse meno sconveniente diventare polacco: è quanto si verifica in accordo con un altro modello, per certi versi considerato opposto a quello scandinavo. È nota la caratterizzazione della nazione polacca come (a seconda delle proprie preferenze) paradiso o inferno “clerico-fascista”: in realtà pure laggiù la situazione politica è composita, se non equivoca e caotica. Non è un caso che l’attuale primo ministro del Paese, Mateusz Morawiecki, abbia pubblicato sui propri social un video di quanto è accaduto negli ultimi giorni a Nanterre e Marsiglia, per rivendicare un modello fatto di sicurezza all’esterno dei confini e salvaguardia dell’ordine pubblico all’interno di essi.
Nasz plan to Europa Bezpiecznych Granic – bezpieczeństwo i porządek publiczny – to są wartości, od których wszystko inne się zaczyna! pic.twitter.com/9anvfDU11d
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 30, 2023
Visto che stiamo parlano dei polacchi, aggiungiamo che, ad onta delle dicerie sullo sciovinismo soverchiante di tale popolo, è un dato di fatto che da quelle parti la gauche caviar abbia la stessa sproporzionata esposizione mediatica di cui gode in altre nazioni europee.
Lo si può notare in un caso recente, un’intervista al pugile di origine nigeriana Izu Ugonoh in un talk show del canale generalista TVN, nel quale la conduttrice tentando insistentemente di fargli dire che i polacchi sono razzisti, ha sortito l’effetto opposto, obbligando l’atleta africano a una manifestazione quasi eccessiva di patriottismo.
Episodi di tal fatta, sempre a discapito dei pregiudizi verso Varsavia (o forse proprio a conferma di essi), sono all’ordine del giorno: si veda ancora l’invettiva (censurata da YouTube) del parlamentare di origine malgascia Erwin Rabarijoely contro l’invasione islamica e l’ingerenza “europeista”, paragonata a quella sovietica .
Da tutto ciò potremmo dedurre che la questione dell’integrazione non è affatto legata a un singolo modello, ma che invece dipende, per usare un’espressione in voga, dalla resilienza di esso di fronte alle esigenze di dogmatizzazione, irrigidimento, identitarismo ecc…
Per la solita eterogenesi dei fini, un giorno forse saremmo costretti ad ammettere che la socialdemocrazia poteva funzionare solo in una società in cui l’etnocentrismo, per quanto “discreto”, facesse da indispensabile collante alla coesione e alla lealtà di gruppo, mentre di fronte alle meraviglie dell’etnopluralismo essa pare rivelarsi come strada maestra alla guerra civile.





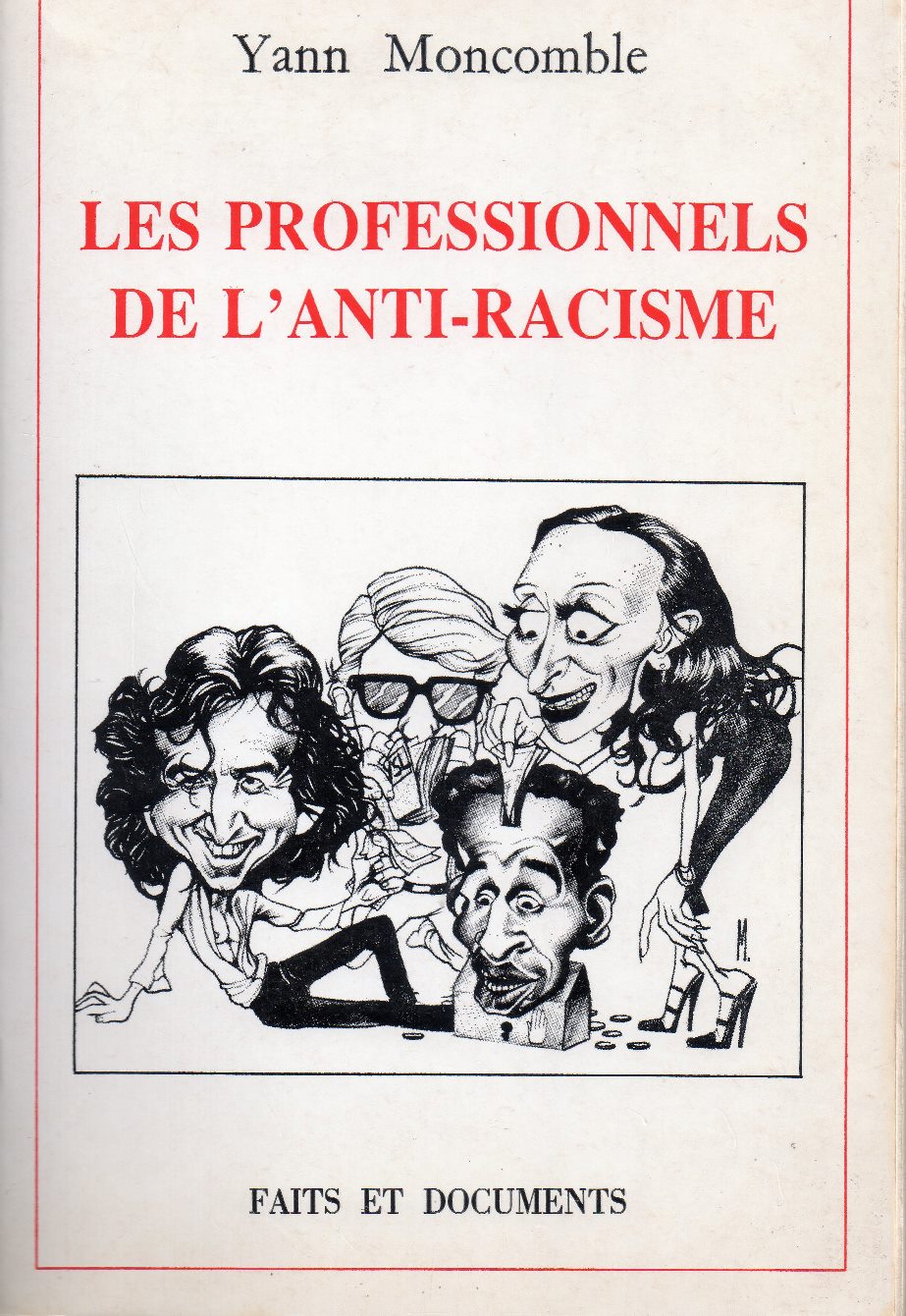


https://italiacoloniale.com/2017/05/01/viva-il-duce-viva-il-re-lonore-di-scire-lascaro-ancora-fedele-allitalia/
Mi sembra di ricordare un servizio relativo di un TG. A quanto ricordo, quando il contingente italiano se ne andò definitivamente, Scirè e la sua famiglia furono portati con un ponte aereo, in una giungla, dal lato opposto della Somalia, presso la loro tribù d’origine, Tutti vennero prima accolti e poi salutati in pompa magna.