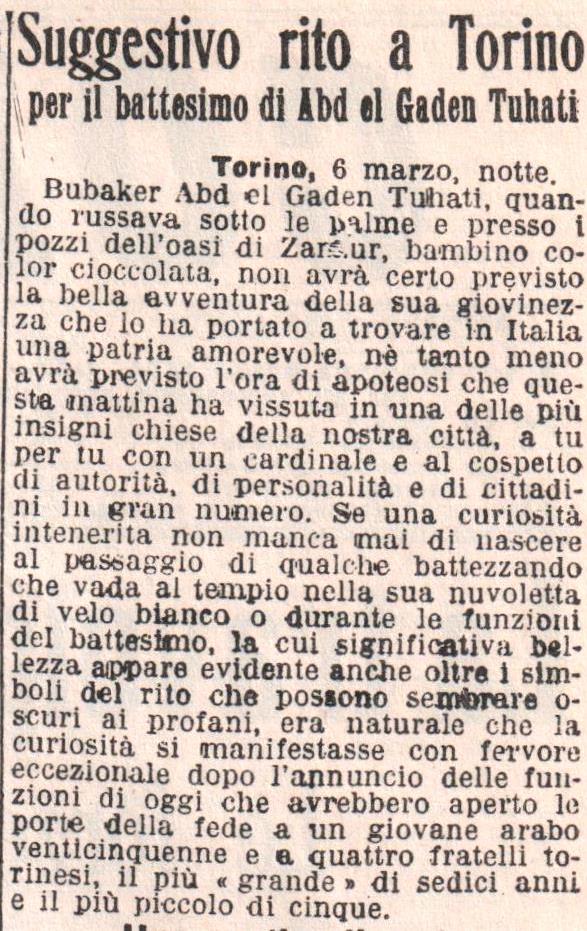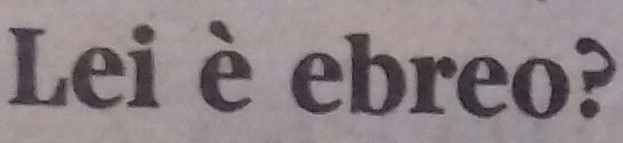
Stefano Lorenzetto, intervistando per il “Corriere” un Marcello Foa fresco di nomina alla dirigenza della Rai, ha voluto porgli una domanda piuttosto equivoca: “Lei è ebreo”?
Lei è ebreo? Glielo chiedo solo perché i suoi detrattori l’accusano persino di questo.
«No, sono cattolico, come i miei genitori. La mamma, greca, nacque ortodossa. Era ebreo il nonno Egizio, che s’innamorò di una cattolica e la sposò».
Dubito che il “Corriere” abbia aderito all’iniziativa di “Russia Insider” di rompere il tabù dell’antisemitismo: d’altro canto un “incidente” del genere solitamente scatenerebbe una canea di dimensioni bibliche, a meno che Lorenzetto non avesse già messo in conto la feroce avversione nei confronti di Foa da parte degli “ambienti che contano”.
In effetti gli attacchi più sguaiati al nuovo diretto della Rai non sono arrivati dai neonazisti, ma da una professoressa parapiddina («Ci sono sempre stati ebrei alleati del fascismo, anzi fascistissimi, onorati e remunerati. Foa non è una novità. Ma si ricorda come finirono gli Ovazza? Bruciati in una stufa») e da Moked, che si autoproclama “portale dell’ebraismo italiano”:
«La Rai viene data a un certo Marcello Foa. E basta leggere i resoconti sulla sua carriera al Corriere del Ticino e sui suoi rapporti con la Russia di Putin per farsi un’idea di quanto tenga all’obiettività dell’informazione e alla democrazia del nostro paese. Per fortuna Marcello Foa sembra non avere rapporti con l’ebraismo, altrimenti si sarebbe potuto sospettare che la sua candidatura fosse stata pensata per creare altro antisemitismo».
Osserviamo giusto un paio di cose: in primis la profonda ipocrisia dell’ebraismo italiano nei confronti di Vladimir Putin (che è poi un riflesso di quella su Israele), come se il Presidente russo non fosse considerato dalle comunità ebraiche internazionali come uno dei dei leader più filo-semiti al mondo, anche per motivi personali (la sua famiglia condivideva lo stesso appartamento con una ebraica); è un segreto di Pulcinella il fatto che grazie a lui i rapporti tra Russia e Israele, seppur tra altri e bassi (più per motivi geopolitici che altro) non siano mai stati tanti buoni.
Dicevamo dell’ipocrisia. Le comunità ebraiche occidentali negli ultimi decenni hanno conosciuto un fenomeno paradossale ma ormai dilagante: quello dell’ebreo progressista in patria e reazionario in Israele. In Francia è noto a quali esiti abbia portato il doppio standard: una spaccatura profonda nella comunità stessa, che ha poi costretto molti a rifugiarsi in Israele dopo la recrudescenza dell’antisemitismo tra le seconde generazioni di arabi (perché l’ebreo parigino, pur di non rinunciare alla propria identità gauchiste, preferisce fare direttamente aliyah).
Gli esempi d’Oltralpe sono numerosi: tra i casi più illustri, ci sono Marek Halter e André Glucksmann (oggi rimpiazzato dal rampollo Raphaël), e ovviamente il più chiassoso di tutti, Bernard-Henri Lévy. Costui è il campione della “disciplina” sin dai suoi esordi come nouveau philosophe: si ricorda, solo per fare un esempio, un’intervista a “France-Soir” dell’aprile 1979, nella quale egli riuscì contemporaneamente a elogiare quei francesi che, votando sinistra alle prime elezioni europee, avevano «contribuito a distruggere le mitologie reazionarie dello Stato-nazione, lo sciovinismo delle coccarde, la Francia dei territori, delle cornamuse e del folklore», e a proclamare l’assoluta necessità di difendere i sacri confini della nazione israeliana, poiché gli ebrei «hanno inventato la giustizia, la libertà, la resistenza, e Dio stesso».
Il discorso c’entra moltissimo con il trattamento riservato a Marcello Foa, che viene trattato da “parente povero” nonostante dal punto di vista etnico avrebbe più diritto di definirsi “ebreo” rispetto a tutti i khazzari (absit iniura verbis) che ci circondano (non risultano comunque sue dichiarazioni a sostegno di Israele).
Per allargare tuttavia il discorso alla sua “area”, non è ridicolo che rabbini e intellettuali semiti impartiscano lezioni di moralità quando tutti i leader dei principali movimenti populisti in Europa (Matteo Salvini, Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders) dichiarano apertamente di ispirarsi al modello sionista? Anche loro “parenti poveri”, seppur solo dal punto di vista politico?
Un notevole case study italiano, sul modello di Bernard-Henri Lévy, è rappresentato invece dal noto Roberto Sav1an0, che nel corso degli ultimi anni ha rivelato una marcata propensione alla grafomania, in particolare nei confronti di quelle cause che entusiasmano appunto i radical chic. Eppure anche chi segue saltuariamente le sue imbarazzanti reprimende, si sarà accorto che il Nostro, pur spaziando dall’Inghilterra alla Russia, dalla Turchia all’Iran, dal Messico alla Siria, quando si tratta di dire qualcosa contro Israele diventa subitamente afasico.
Il motivo è anch’esso risaputo: Sav1an0 nutre per Israele un amore incondizionato. A differenza però della “generazione Kibbutz”, lo scrittore rivendica un altro tipo di “radici” e un altro tipo di “appartenenza”. Come dichiarò in un’intervista ad “Haaretz” (M. Rapoport, Not afraid to die, 24 settembre 2007), egli vive il suo blando retaggio giudaico in maniera totalmente eterodossa:
«Ho fatto alcune ricerche e ho scoperto che mia madre aveva radici sefardite. Mio nonno mi ha educato al giudaismo e alla Torah. Mi ha sempre attratto molto Sabbatai Zevi e l’anarchismo ebraico. Questa è l’atmosfera nella quale sono cresciuto, ma non ho mai voluto renderlo pubblico. È l’ultima cosa di cui ho bisogno. In Italia sembrerebbe qualcosa di esoterico».
Il riferimento al sabbatianesimo potrebbe risultare sconcertante, ma penso che, come al solito, Sav1an0 non conosca realmente ciò di cui parla (anche se è vero che alcuni ebrei sefarditi lo considerino ancora il messia). Ad ogni modo, non è solo tenendo una menorah sul tavolo di casa che Sav1an0 sostiene Israele: è soprattutto perché, come egli stesso ha dichiarato, laggiù “si sente al sicuro”. Quale orgoglio deve essere stato, in occasione di uno dei numerosi viaggi nella Terra Promessa, sentirsi dire da Shimon Peres in persona queste rassicuranti parole:
«Anche noi abbiamo la nostra camorra, caro Sav1an0. Si chiama Hamas. Non ha un obbiettivo razionale. È brutale. Ammazza anche le sue donne e i suoi bambini. È la nostra mafia incivile».
Riconosciamo almeno a Sav1an0 di avere una visione più chiara dei motivi per cui, a suo dire, qualcuno dovrebbe amare Israele: non è per lui una questione “sentimentale” (se così si può dire), di “radici” che vanno difese sempre e comunque. La sua è una scelta consapevole, radicale, intransigente: anche se, a dirla tutta, per ipocrisia viene “mascherata” con un’appartenenza etnico-religiosa che d’altra parte non sembra influenzare poi di molto le sue idee o la sua prosa (perlopiù assimilabile a quella di qualsiasi intellettuale liberal contemporaneo, a meno che non si voglia ipotizzare un’ispirazione sabbatiana più profonda, ma questo è un altro discorso).
È come se ci trovassimo al cospetto di una sorta di “patriottismo surrogato”, che per esprimersi ha sempre bisogno di costruirsi un alibi delle “origini”, delle “radici”, col quale scongiurare qualsiasi accusa di “nazionalismo”, “sciovinismo” o, perché no, fascismo. Non pare quindi una scelta molto coraggiosa, quella di difendere una nazione in base a principi che si rifiuterebbe anche solo di considerare quando venissero applicati dalla nazione in cui si è nati e vissuti, e di utilizzare come scudo a eventuali critiche la propria “identità”.
Alla luce di tutto questo, diventa difficile rispondere alla domanda su chi davvero sia l’Ebreo, oggi, in Italia (e in Europa). Il recente “revival”, animato da personalità culturali di altissimo livello (come Lapo Elkann), deve fare i conti con la realtà materiale delle liste chilometriche di cognomi sefarditi, di una storia che ci racconta che «prima del 1500, circa il 40% della popolazione totale della Calabria e della Sicilia era di origine ebraica» e perciò della concretissima possibilità che una larga fetta di popolazione italiana un giorno possa rintracciare la “trisavola” con cui costruirsi una reputazione mediatico-politica (all’occorrenza ci si può rivolgere ai laboratori specializzati in “radici ebraiche” come Igenea, che per la modica cifra di 179€ vi faranno sapere se siete “un Levi o un Cohen”).
La stereotipizzazione ai limiti della schizofrenia (come dicevamo: l’ebreo “piddino” in patria e likudnik in Israele) non fa di certo bene a un’identità in bilico tra assimilazione ed eccezionalismo, soprattutto quando l’intellighenzia ebraica si fa custode del “politicamente corretto” nei rispettivi Paesi di appartenenza. La conseguenza più spiacevole di tale dogmatismo l’abbiamo già ricordata: la fuga degli ebrei dalle periferie delle metropoli europee devastate dall’immigrazione che le loro stesse comunità hanno attivamente sostenuto sotto ogni punto di vista (anche quello culturale e spirituale, shoahizzando il fenomeno con l’istituzione di assurdi paragoni tra masse di giovani arabi e sopravvissuti ai campi di concentramento). Per quanto tragica, questa auto-distruzione dell’ebraismo europeo ha numerosi risvolti ridicoli, come la vicenda recente del palestinese che pur avendo dato fuoco a una sinagoga di Göteborg non può essere deportato perché nei territori occupati da Israele rischierebbe una pena più severa di quella comminata dalla giustizia svedese.
Ci sono però effetti meno eclatanti ma più sottilmente fastidiosi, come l’imposizione alla cittadina spagnola di Castrillo Matajudíos (“ammazza ebrei”) del nome di Castrillo Mota de Judíos (“collina degli ebrei”). Sembra un’inezia, ma la campagna di “sensibilizzazione” di pochi anni fa fu lanciata pur con la consapevolezza che “mata” in spagnolo è un sinonimo di “mota”, e che quindi Castrillo era sempre stata la “collina” degli ebrei. Questo solo per riportare l’esempio più innocuo di una tendenza alla “pulizia verbale” che assomiglia alla pura e semplice censura (ovviamente sempre selettiva): un altro elemento insostenibile di una “identità ebraica” che sembra seguire le regole de La fattoria degli animali.
E allora, chi ha diritto di rispondere alla domanda “Lei è ebreo?”, se non chi ha già sgranato il rosario (sempre absit iniuria verbis) dell’infinita serie di peccati moderni, rispondendo affermativamente ad altri impellenti interrogativi (“Lei è progressista? è liberale? europeista? femminista? pacifista? vegano? omosessuale? ateo?”) e trasformandosi in una caricatura che nemmeno i più ferventi antisemiti avrebbero potuto immaginare.
*
Aggiornamento (28 settembre 2018): Stefano Lorenzetto si è scusato per aver posto quella domanda.
«Nell’intervista pubblicata ieri sul Corriere ho posto a Marcello Foa una domanda per denunciare un intollerabile e ripugnante rigurgito antisemita. Con il senno di poi, mi rendo conto che la risposta fattuale di Foa (“Sono cattolico”) ha contribuito a rafforzare l’equivocità del quesito. Si chiama eterogenesi dei fini: volevo difendere gli ebrei, che amo, e non ci sono riuscito, ingenerando in taluni la sensazione opposta. Mi scuso per questa incapacità nel rappresentare i sentimenti dell’intervistato e dell’intervistatore».